|
LA SCHEDA INFORMATIVA
BAROCCO
Il '600 fu per Acireale il secolo d'oro dell'architettura
barocca, sia quella più evidente del Palazzo di città, della
Basilica di S. Sebastiano e dei palazzi di via Dafnica, sia
quella più semplice dei quartieri popolari, dei tracciati di via
Galatea e del quartiere delSuffragio.
Il terremoto del 1693 danneggiò i magnifici monumenti del
centro, ma la successiva ricostruzione trionfa nel barocco della
Basilicadi S. Sebastiano; del complesso di Piazza Duomo con il
trilatero del Duomo, della Basilica dei SS. Pietro e Paolo, del
Palazzo di Città; della loggia del Monastero delle Benedettine;
dei palazzi neoclassici di corso Umberto e corso Savoia.
Tutta la città conserva intatte le forme del barocco siciliano,
nelle case, nei portali lavici dai mascheroni scolpiti,
nell'intreccio delle vie.
ZAFFERANA ETNEA
LA STORIA
Il borgo si sviluppò con l'insediamento in valle San Giacomo dei
frati Benedettini, che fondarono un monastero nella vigna "Ursina",
dove sorgeva anche una chiesa dedicata a San Giacomo. Il
toponimo più antico di Zafferana è "Cella", che indicava la
stessa contrada denominata San Giacomo. Il toponimo Zafferana si
rileva invece in alcune carte del 1694. Il suo significato
deriverebbe dall'arabo "Zafarana", ossia contrada ricchissima di
acqua. Un'altra ipotesi fa derivare il nome del paese dall'arabo
"Zaufanah", ovvero "giallo", per le grandi estensioni di
ginestre che si trovano nel suo territorio. Altra teoria ammette
la possibilità che il paese è stato così battezzato per le sue
coltivazioni di zafferano. Il primo nucleo abitato si sviluppò
verso la fine del 1600 attorno alla chiesa di San Giacomo. Nel
1792 la lava dell'Etna divorò numerosi frutteti e vigneti della
zona. In quell'occasione i fedeli portarono in processione il
simulacro della Vergine Maria invocando il miracolo di bloccare
la forza distruttrice del vulcano. La colata si fermò a poche
centinaia di metri dal paese. Nel 1818 un violento terremoto
colpì il paese, distruggendo numerose abitazioni e mietendo 34
vittime. Nel 1820 Zafferana divenne comune autonomo.
ZAFFERANA
ETNEA OGGI
Anche in questo secolo le eruzioni dell'Etna hanno più volte
minacciato Zafferana Etnea, senza mai, però, arrecare
significativi danni. Proprio all'Etna Zafferana deve la sua
fortuna. Il turismo è infatti una delle sue principali fonti di
reddito (18.000 presenze alberghiere annue). Nel settore
dell'artigianato notevole è la produzione di souvenirs che
incontrano il favore dei turisti. Sviluppata è anche
l'agricoltura.
I MONUMENTI
I monumenti di Zafferana Etnea sono prevalentemente in stile
barocco.
Notevole è la Chiesa Madre, ricostruita dopo il terremoto del
1817 ed intitolata alla Madonna della Provvidenza; è
fiancheggiata da due campanili gemelli e la sua facciata, in
pietra bianca, contrasta in maniera suggestiva con la nera
scalinata in pietra lavica. Al suo interno vi si conservano
alcune opere del locale pittore Giuseppe Sciuti (1834-1911). In
stile liberty è invece il Palazzo Comunale dove sono conservate
altre mirabili opere di G.Sciuti. Altri monumenti da ricordare
sono la Chiesa della Madonna delle Grazie, il Parco Comunale, la
Villa Manganelli, la Villa Gravina e la Villa Tripi.
LE
RICORRENZE
Agosto (1^ domenica): festeggiamenti in onore della Madonna
della Provvidenza, patrona del paese.
Settembre: assegnazione del premio letterario "Vitaliano
Brancati".
Ottobre: assegnazione del premio "Polifemo d'argento" per
l'arte, la cultura e lo sport .
GIARRE
LA STORIA
Pare che nel territorio dell'attuale Giarre sorgesse la città
greca di Callìpoli, fondata da coloni calcidesi nel VII secolo
a.C.. Le prime notizie del borgo risalgono al XVIII secolo,
quando si formò il primo nucleo abitato alla dipendenza della
Contea di Mascali, feudo ecclesiastico. Lo sviluppo di Giarre
appare legato alla sua felice posizione sulla via consolare che
univa Catania con Messina. Il suo nome è da attribuirsi allle
stazioni di posta dove si trovavano le giare a cui i cavalli
potevano abbeverarsi. Il borgo si staccò da Mascali nel 1815,
poco dopo la soppressione dei feudi e fu costituito in comunità
autonoma.
GIARRE
OGGI
Giarre comprende le frazioni Altarello, Carruba, Macchia, San
Giovanni, San Leonardello e Trepunti. Oggi è uno dei centri più
dinamici della provincia soprattutto per quanto riguarda il
commercio di primizie di frutta e ortaggi. Fiorenti sono la
viticoltura e l'agrumicoltura e buono è il patrimonio
zootecnico. L'industria è presente nei settori della
pastificazione, meccanico, estrattivo e dei materiali da
costruzione. Vi sono anche fabbriche di dolci, , di mobili e di
imballaggi. Buone risorse sono anche il turismo estivo (12.000
presenze alberghiere annue) ed il commercio.
I MONUMENTI
Gli edifici antichi si presentano prevalentemente
baroccheggianti con qualche eccezione neoclassica come il
Duomo,
edificato nel secolo scorso ma completato di recente, dotato di
una splendida cupola. Notevole anche la Chiesa di Sant'Isidoro e
alcuni palazzi nobiliari.
LE
RICORRENZE
10 maggio: festeggiamenti in onore di Sant'Isidoro, patrono di
Giarre.
Maggio: sagra delle ciliege e delle rose.
Settembre: fiera dell'agrumicoltura, ortofrutticoltura e
industrializzazioni agricole.
Settembre: mostra-mercato dell'artigianato siciliano
ACIREALE
LA STORIA
È nella mitologia che Acireale trae il suo nome, e più
precisamente alla leggenda dei Ciclopi (cantata dai poeti greci
e dai latini Ovidio e Virgilio), legata alla storia d’amore tra
la ninfa Galatea e il pastore Akis (in latino Aci), perseguitato
dal rivale Polifemo e trasformato poi in fiume dal Dio del mare
Poseidone. Sulle rive del fiume Akis, oggi scomparso, vissero
popolazioni primitive e, verso la fine del VIII secolo a.C.,
coloni greci vi fondarono una città dal nome Akis, della quale
non è mai stata identificata l’esatta ubicazione. Centro
importante dopo l’occupazione romana, ebbe un ruolo rilevante
durante la prima guerra punica (III secolo a.C.), e alla fine
del II secolo a.C. vi si concluse la guerra servile (101 a.C.).
Prese allora il nome di Aquilia in onore del console romano
Aquilio Manio Nepote, amico di Mario, vincitore sugli schiavi
ribelli siciliani. Sotto i bizantini Aci, a difesa delle
frequenti incursioni saracene, fu munita di un forte castello,
che verso la fine del IX secolo servì da rifugio agli abitanti,
durante l’ultima fase dell’invasione araba della Sicilia. Nel
XII secolo fu interamente distrutta (in parte dal terremoto del
1169 e in parte dall’eruzione dell’Etna). Gli acesi si
dispersero nei dintorni e fondarono numerose borgate, alcune
delle quali furono battezzate Aci, mentre non lontano dalla
città distrutta un nucleo più nutrito di profughi fondò Aquilia
Nuova, che ebbe subito un rapido sviluppo. Ma nel 1326 una
violenta incursione della flotta del re di Napoli ed un incendio
di vaste proporzioni spinsero gli abitanti a rifugiarsi
sull’altopiano dove sorge l’odierna città. Realizzata con un
disegno più ampio ed arricchita di edifici pubblici e religiosi
nei secoli successivi, nel 1642 prese il nome di Acireale per
decreto del Re di Spagna Filippo IV, che l’affrancò da ogni
vincolo o ipoteca feudale assoggettandola direttamente alla
corona. Il terremoto del 1693 danneggiò gravemente la città, ma
non al punto, come invece era accaduto in passato, di dover
essere abbandonata dalla popolazione. Si riprese rapidamente
divenendo un importante centro commerciale, si sviluppò sul
piano edilizio e fu dotata di monumenti e di nuovi edifici,
acquistando un suo ruolo anche sul piano della cultura con la
fondazione di alcuni istituti e nel 1844 fu eretta a sede
vescovile.Vi nacque il pittore Pietro Paolo Vasta (1697-1760)
che tra il 1720 e il 1750 dipinse affreschi tra i più belli mai
realizzati in Sicilia.
ACIREALE
OGGI
Oggi Acireale è un attivo centro commerciale, sede di numerose
industrie. Vi sono pastifici, industrie per l’imbottigliamento
di acque minerali, cave di pietra, miniere di zolfo e numerose
imprese artigiane. Nel settore agricolo prevale l’agrumicoltura,
che interessa circa 2500 ettari di terreno coltivato, seguita
dalla viticoltura. Numerose sono le imprese attrezzate per la
lavorazione e l’esportazione di limoni. Altra importante e
fondamentale risorsa di reddito è il turismo: Acireale è infatti
una rinomata e attrezzata località climatica, termale e
balneare; ha una media di 30.000 presenze alberghiere ogni
estate (in netto aumento negli ultimi anni le presenze
straniere) e richiama a carnevale un altissimo numero di
visitatori da tutte le parti della Sicilia.
I MONUMENTI
Nessun monumento cittadino risale al di là del periodo barocco,
ma importanti testimonianze archeologiche, tra cui un famoso
busto di Giulio Cesare, sono raccolte nell’edificio della
biblioteca e pinacoteca Zelantea, mentre una preziosissima
collezione di monete antiche è custodita nel palazzo Pennisi di
Fioristella. Le numerosissime chiese barocche si dividono in due
gruppi, uno risalente al ‘600, in cui si fondono varie tendenze
stilistiche, ed uno al ‘700.
Al primo gruppo appartengono, oltre alla prima costruzione del
Duomo (poi successivamente rimaneggiato) col bel portale
barocco, l’armoniosa Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la grande
Basilica di San Sebastiano, con vasta e bella facciata di
struttura ancora tardo rinascimentale a tre piani e stupendi
affreschi di A. d’Anna.
Al ‘600 appartiene anche il Palazzo Comunale (1659) con belle
decorazioni scultoree di fastoso gusto spagnolesco. Numerose le
Chiese del ‘700 (spesso decorate dagli affreschi di P.P.Vasta):
San Camillo dei Crociferi, dall’accordo assai armonioso tra
architettura e decorazione, S.Maria del Suffragio, S.Antonio, la
Maddalena, il Carmine, S.Domenico ed altre, non di rado
rimaneggiate.
Altre opere da ricordare sono: il Palazzo del Fiorentino, il
Santuario Madonna di Loreto, le Terme di S.Venera, la Chiesa dei
Filippini.
LE
RICORRENZE
Carnevale: "il più bel carnevale di Sicilia", con sfilata di
carri allegorici, carri infiorati, gruppi in maschera, concerti,
spettacoli.
24-27 luglio: festeggiamenti in onore della patrona Santa Venera
con tradizionali manifestazioni folcloristiche, rappresentazioni
teatrali e spettacoli in genere.
Gennaio: festa di San Sebastiano con processione solenne. Il
fercolo del Santo è montato su un carro di legno (detto "Vara")
che sfila lungo le vie della città.
24-27 luglio: fiera nazionale del bestiame.
CATANIA
LA STORIA DI
CATANIA
(fino all'anno 500 d.C.)
La catena collinare che circonda Catania
suggerì il primo nome,
"Catinon", al primitivo villaggio siculo sorto in prossimità
della foce del fiume Amenasos, nel periodo eneolitico. Qui,
nella fase conclusiva della penetrazione greca in Sicilia,
intorno al 729 a.C., si insediò una colonia di Calcidesi,
guidata da Tucle, l'uomo che aveva fondato Nasso e
successivamente Lentini, dando vita ad un nuovo agglomerato, una
vera acropoli sull'altura sovrastante il villaggio. La nuova
colonia greca conobbe subito un rapido sviluppo, sul piano
edilizio, organizzativo, legislativo e culturale. Nel VII secolo
a.C., Caronda dette a Catania un codice di leggi scritte, estese
in seguito a tutte le città siceliote. Il poeta Stesicoro ed il
filosofo Senofane, fondatore della setta eleatica, la scelsero
come propria residenza. Fu dotata di templi, di teatri, di
terme, di una zecca e di un erario e fu visitata dai poeti e
dagli uomini più colti della Grecia. Ma la prosperità e
l'espansione costante non potevano non suscitare gelosie e
contrasti con la vicina Siracusa, che già agli inizi del V
secolo a.C. si era assicurata una parziale supremazia su
numerose città dell'Isola. Nel 476 a.C., rompendo ogni indugio,
il tiranno di Siracusa Gerone conquistò Catania, fece trasferire
la popolazione a Lentini sostituendola con coloni dorici e le
impose il nome "Etna". Ma la reazione dei calcidesi contro
Gerone e contro il successore Trasibulo fu tale che pochi anni
dopo (461 a.C.) assediarono Etna, la riconquistarono scacciando
i coloni dorici (che si trasferirono ad Inessa, cui diedero il
nome Etna) e le ridiedero l'antica denominazione. Ma i contrasti
con Siracusa continuarono non soltanto per le differenziazioni
etniche quanto piuttosto per esigenze di ordine vario legate
alle mire espansionistiche di entrambe, alla inevitabile
concorrenza commerciale e al problema della sicurezza militare.
Questi contrasti esplosero come una conseguenza della guerra del
Peloponneso: Catania si offrì ad Alcibiade come base delle
operazioni militari contro Siracusa (415 a.C.). Nel 403,
Dionisio di Siracusa si impossessò di Catania che fu duramente
saccheggiata: gli abitanti furono in parte allontanati ed in
parte venduti come schiavi e la città fu ripopolata con
mercenari che erano stati assoldati in Campania, in Calabria ed
in Puglia. Ma questi l'abbandonarono nel 396 a.C. sotto la
minaccia della flotta cartaginese, comandata da Magone e
Imilcone che conquistarono Catania e la presidiarono, dopo aver
sconfitto la flotta siracusana. Conquistata dall'ateniese
Callippo (353 a.C.), nel 345 cadde sotto la tirannia di Mamerco
il quale, unitosi con Timoleone, tiranno di Siracusa, contribuì
a restituire ai Greci una larga prevalenza su tutta la Sicilia
(338 a.C.). Ma Catania aveva ormai perduto le sue
caratteristiche elleniche, per cui fra le prime città dell'isola
ad aprire le porte a Pirro, re dell'Epiro, e in seguito a Roma,
che la occupò nel 263 a.C., le dette il nome di Catina o Catana
e l'annoverò tra le città decumane. Sotto la dominazione romana,
che assicurò lunghi periodi di pace, Catania si sviluppò
economicamente e demmograficamente, grazie alla sua stessa
posizione sul mare ed al volume dei suoi commerci non più
turbati dall'invadenza siracusana. Gravemente danneggiata
durante la prima guerra servile (138 a.C.), fu semidistrutta da
un'eruzione dell'Etna nel 121 a.C. e fu letteralmente depredata
dal propretore Verre, come testimoniano le denunce di Cicerone.
Durante la guerra civile parteggiò per Sesto Pompeo e nel 21
a.C. Augusto vi insediò una colonia di veterani, accelerandone
così il processo di latinizzazione e di integrazione delle
minoranze etniche, nonchè una trasformazione sul piano culturale
e giuridico. Sotto Roma, Catania ampliò sensibilmente il
perimetro urbano e fu cinta di mura. Fu dotata di teatro e di
terme, di foro e del circo, del ginnasio e dell'anfiteatro,
nonchè di un grandioso acquedotto, mentre furono restaurati gli
edifici del periodo greco. Eretta a municipio romano, fu la sede
del maggior magistrato romano in Sicilia fino alla tarda età
imperiale. E con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente (476
d.C.), Catania non fu coinvolta nella crisi generale, ma ebbe
invece un impulso nelle attività edilizie e agricole,
soprattutto con l'insediamento di comunità ebraiche ed
orientali, che ebbero un loro ruolo nell'incremento
dell'economia, della produzione commerciale e artigiana.
LA STORIA DI
CATANIA
(dopo l'anno 500 d.C.)
Con l'occupazione dei Vandali, degli Eruli, dei Goti, degli
Ostrogoti ed infine dei Bizantini di Belisario (535), Catania
non subì arresti nella prosperità economica, anzi se ne
avvantaggiò, nella metà del VI secolo, grazie allo spostamento
verso Oriente dei traffici marittimi e con il trasferimento in
città della zecca dell'impero bizantino nonchè con le pressanti
richieste di derrate e di legnami da parte di Costantinopoli,
per sostenere la concorrenza delle flotte musulmane nel
Mediterraneo. Ma con lo sbarco degli Arabi e la conquista di
Palermo (831), Catania risentì, come le altre città siciliane,
del clima di incertezza e di costante minaccia e fu gravemente
colpita nella sua economia dalle frequenti incursioni che si
protrassero per tutto il IX secolo. Se riuscì a sostenere
vittoriosamente l'assedio musulmano del 900, finì col perdere la
propria indipendenza e quindi il carattere omogeneo della sua
popolazione con forti infiltrazioni di berberi e di
arabi-orientali, pur rimanendo una importante città marittima.
Verso il 1040, con la disgregazione del dominio arabo, Catania
fu sede di una signoria e teatro di scontri tra i vari emiri in
lotta per il possesso di tutta l'isola, l'ultimo dei quali, Ibn
at-Thumnah, invocò l'intervento dei Normanni (1060). Nel 1071,
la città fu occupata dal conte Ruggero d'Altavilla come alleato
degli Arabi, ma suscitò una rivolta con il suo comportamento.
Neutralizzati i Musulmani, Ruggero concesse la città in feudo ad
Angerio (1082), il bretone abate dell'abbazia benedettina di
Sant'Agata, consacrato vescovo dieci anni dopo. Sotto i
Normanni, per quanto fossero favorite Messina e Siracusa,
Catania prosperò, grazie ai ricchissimi prodotti
dell'entroterra, ai pregiati legnami dell'Etna, alla pece di
Mascali. Ma questo processo di sviluppo fu bruscamente
interrotto dal terremoto del 1168 che provocò ingentissimi danni
e ben quindicimila vittime. La ricostruzione fu rapida, ma nel
1194 Enrico IV di Svevia ne ordinò il saccheggio e la
demolizione di alcuni edifici, per punirla di aver parteggiato
con Tancredi. Federico II la tolse alla signoria dei vescovi e
fece costruire il castello Ursino (1239), non solo per la difesa
della costa, ma per fronteggiare eventuaali insurrezioni della
città dalle tradizioni guelfe. Coinvolta nei moti del Vespro
(1282) che si conclusero con la cacciata degli Angioini e dei
Francesi, Catania riprese a prosperare con l'avvento della
dinastia aragonese (1296), grazie ad alcune riforme di natura
amministrativa e politica, nonchè della concessione di privilegi
e di esenzioni fiscali che la posero su un piano competitivo con
Palermo e Messina. Dal 1342 e fino agli inizi del XV secolo fu
spesso sede della corte aragonese. Alfonso il Magnanimo confermò
i vecchi privilegi e ne concesse altri, promosse la costruzione
del molo (condotta a termine, però, solo nel XIX secolo), e
soprattutto concesse a Catania la prima Università della
Sicilia, il Siciliorum Gymnasium (1434), col privilegio
dell'unicità rispetto alle richieste di Palermo e Messina, che
divenne centro di ripresa per gli studi e la cultura classica.
Ma lo studio non fu sufficiente a salvare la città dala crisi
che travolse tutta la Sicilia durante la dominazione spagnola,
contro la quale Catania insorse parteggiando con il moto di
Giuseppe d'Alesi (1647-48). E la crisi economica fu trasformata
in tragedia dalla più grande eruzione dell'Etna che la storia
ricordi, nel 1669. La parte occidentale della città fu raggiunta
e sommersa da un fiume di lava largo due chilometri, che
travolse anche una larga parte del porto. Ancor più disastroso
fu il terremoto del 1693 che provocò la quasi totale distruzione
della città e bben sedicimila vittime. La ricostruzione, basata
su una pianta del Lanza, Duca di Camastra, del vescovo Riggio e
del canonico Celestri, eseguita dall'architetto Giovan Battista
Vaccarini, con l'alacre partecipazione dei superstiti, fu
realizzata rapidamente e con un gusto architettonico
sufficientemente moderno e armonico. Rapido fu anche il
ripopolamento: già alla fine del XVIII secolo aveva raggiunto un
numero di abitanti superiore a quello del 1693. Oppostasi
apertamente alla rivoluzione palermitana del 1820, Catania,
insofferente del dominio borbonico, insorse nel 1837, nel 1848 e
infine nel 1860. Nel 1943, durante la seconda guerra mondiale,
fu gravemente danneggiata da ripetuti bombardamenti aerei e
navali e nello stesso anno fu occupata dagli alleati.
Nacquero a Catania: Caronda (VII secolo a .C), legislatore;
Mario Cutelli (1586-1654), giurista, Olivio Sozzi (1699-1765),
pittore; Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari
(1719-1786), archeologo e mecenate; Giuseppe Recupero
(1720-1778), vulcanologo; Giuseppe Gioeni (1747-1822),
naturalista; Vincenzo Bellini (1801-1835), musicista e
compositore; Giovanni Pacini (1796-1867), musicista; Michele
Rapisardi (1822-1900), pittore; Mario Rapisardi (1844-1912),
poeta; Antonio di San Giuliano (1852-1914), statista; Angelo
Majorana (1865-1910), sociologo; Filippo Eredia (1877-1948),
meteorologo; Angelo Musco (1871-1937), attore; benchè nativo di
Vizzini fu registrato negli archivi anagrafici di Catania lo
scrittore Giovanni Verga (1840-1922).
I monumenti di Catania
I terremoti e le colate di lava, hanno ripetutamente cancellato
monumenti ed opere d'arte della Catania antica: la grande
eruzione del 1669, che ricoprì molti quartieri della città
(conservando però sotto il suo duro mantello importanti reperti
archeologici), ed il terremoto del 1693, costrinsero i catanesi
a ricostruire quasi completamente, in forme nuove e regolari, la
propria città. Catania si presenta come una mirabile città
settecentesca, dalle vie regolari e ben tracciate, dalle piazze
armoniose e dagli sfondi prospettici ben studiati. Quasi tutti i
suoi monumenti, ed in particolare una gran serie di chiese e di
palazzi, appartengono al '700 e compongono, con Noto, il più
unitario esempio italiano di città dell'epoca per architettura e
omogeneità negli stili di costruzione. Non mancano però i
monumenti più antichi: in particolare il patrimonio archeologico
d'età romana è ancora assai ricco. Oltre alle opere raccolte nei
musei sono da ricordare: il Teatro Romano con il vicino Odeon,
il Foro Romano, le Terme di S.Maria dell'Indirizzo, le Terme
Achelliane sotto il Duomo, il Carcere di S.Agata. Poche ma
importanti le opere della prima età cristiana e del periodo
bizantino: i resti della basilica paleo-cristiana sul luogo di
S.Agata la Vetere, la Basilichetta bizantina di Monte Po, la
Basilica del Salvatorello. Al periodo arabo-normanno
appartengono i grandiosi resti del Duomo, ed in particolare il
transetto, le absidi esterne, le basi dei campanili ed altre
strutture rimesse in luce nell'interno.
Il più importante monumento del Medioevo catanese è il
Castello Ursino: eretto sotto Federico II (1239-50), da Riccardo da
Lentini, nelle tipiche e grandiose forme dei castelli svevi, con
grandiose torri cilindriche agli angoli ed altre minori che
scandisconole cortine, è ben conservato, anche in varie sale
interne dalle grandiose coperture, ma mostra anche interessanti
rifacimenti rinascimentali. Ospita un Museo che raccoglie
numerose opere medievali.
Importanti tombe gotiche e strutture di cappelle della stessa
epoca si osservano nel Duomo, il cui portale medievale si può
attualmente ammirare nella Chiesa del S.Carcere.
Di eccezionale importanza sono gli sviluppi dell'arte barocca:
una città completamente settecentesca si innalza sul corpo
martoriato della vecchia Catania, con splendore di rettilinei,
di incroci scenografici, di piazze armoniosamente concepite:
celebri i complessi di via Etnea, di via dei Crociferi, della
piazza del Duomo e della piazza dell'Università.
Alla tendenza spagnolesca appartengono l'esterno del palazzo
Biscari ed il grandioso convento di San Nicolò
(1703), con
finestre ricchissime e, all'interno, chiostri più classicamente
composti.
All'opera di Giovan Battista Vaccarini si devono importantissime
opere catanesi: la facciata del Duomo, la Chiesa di San
Giuliano, il Monastero di Sant'Agata, la famosa
Fontana del Liotru (dell'elefante), il cortile del Collegio Cutelli, il
complesso di piazza Università, il Municipio, la Chiesa di San
Benedetto.Grandi opere sono dovute anche a Stefano Ittar, che
risolve in una nuova e più capricciosa eleganza le forme
vaccariniane. Tra i più significativi monumenti catanesi
ricordiamo: la settecentesca Collegiata, la Chiesa di San
Giuseppe, la Chiesa di Sant'Agata al Borgo, il palazzo Minoriti
(sede della Provincia Regionale di Catania e della Prefettura),
la Chiesa della SS. Trinità, il palazzo Asmundo, la Chiesa di
San Benedetto, la Chiesa di San Giuliano, il
Teatro Bellini, la
Villa Bellini.
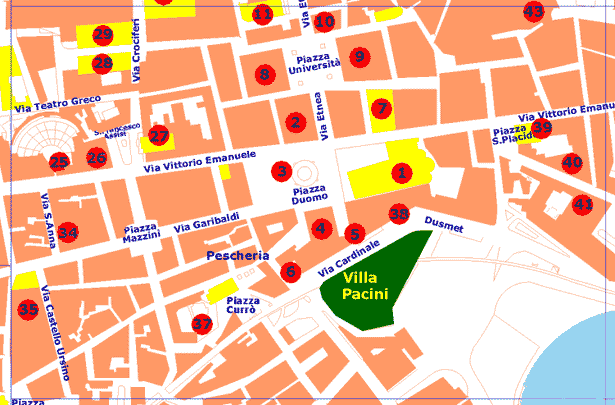
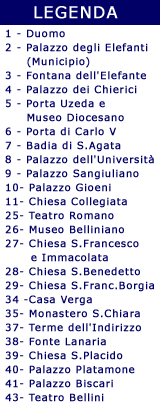
SANTA
VENERINA
LA STORIA
Il territorio fu già abitato in età romana e bizantina, come
dimostrano i notevoli avanzi di terme e i resti di alcune
chiese. Fu un casale compreso nel territorio di Acireale, vicino
ad un antichissimo pozzo, detto "Sanctae Venerae puteus", presso
il borgo denominato Porta. Il borgo attuale venne fondato nei
primi anni del XVIII secolo e fu sempre compreso nel territorio
di Acireale, di cui seguì le vicende. Il comune fu costituito
nel 1934 con parti di territori staccati da Acireale, Giarre e
Zafferana Etnea.
SANTA
VENERINA OGGI
Oggi la viticoltura, l'agrumicoltura e l'ortofrutticoltura
interessano quasi interamente la superficie coltivata.
L'economia di Santa Venerina si basa anche su piccole industrie
e su un attivo commercio.
I MONUMENTI
La Chiesa Madre, dedicata a Santa Venera, è stata costruita nel
1740 e custodisce dipinti settecenteschi di P.P.Vasta.
La Chiesa del Sacro Cuore, con monumentale facciata a tre ordini
e alta cupola, è stata edificata tra il 1875 ed il 1878. Nel
territorio sussistono le rovine di un antico oratorio del VI
secolo.
LE
RICORRENZE
Agosto (1^ domenica): festeggiamenti in onore di Santa Venera,
patrona del paese.
Settembre: mostra di artigianato e di vini tipici.
TRECASTAGNI
LA STORIA
L'origine di Trecastagni è tra le più antiche dei paesi etnei.
Alcuni storici la fanno risalire ai tre accampamenti romani che
sorgevano nel luogo (Trium Castrorum); altri la collegano con
riferimento ai martiri Alfio, Delfio e Cirino "tre casti
agnelli" (tre anime pure) che nel 253 d.C. si sarebbero fermati
nel paese nel corso del loro viaggio verso Lentini; una antica
interpretazione, di origine popolare, ne fa risalire il nome a
tre alberi di castagno che i fratelli martiri avrebbero
piantato. Nel 1302, quando in Sicilia imperversò il potere
angioino, tutti gli abitanti della Val di Demone lo riconobbero,
sottomettendosi alla nuova egemonia, tranne gli abitanti di
Trecastagni, Francavilla, Castiglione di Sicilia e di altri
paesi vicini. I trecastagnesi, ribellandosi, formarono un
piccolo esercito, e alleandosi con gli abitanti dei luoghi
limitrofi, affrontarono e batterono i francesi. Fino al 1640 il
territorio di Trecastagni fu amministrato dal Senato di Catania,
per passare poi, nel 1649, ai don Giovanni. Nel XVIII secolo il
paese venne quindi ceduto agli Alliata. Nei moti rivoluzionari
del 1837 i trecastagnesi furono i più attivi tra tutti i
cittadini dei paesi etnei a partecipare all'insurrezione. Un
notevole contributo fu dato dai trecastagnesi alla causa
dell'Unità d'Italia, come testimoniato nelle pubblicazioni
dell'epoca.
TRECASTAGNI
OGGI
Oggi Trecastagni è una cittadina tranquilla. Vi sono vasti
boschi di castagni, querce e pini, che vengono intensamente
sfruttati. Buone risorse sono la pastorizia e il commercio,
particolarmente attivo in estate, grazie al movimento turistico.
Vi operano piccole industrie.
I MONUMENTI
Il Santuario dei Santi Alfio, Delfio e Cirino: il Santuario
venne costruito nel 1593 e viene considerato oggi uno tra gli
edifici più importanti del '500 siciliano. All'interno conserva
un calice d'argento del '600 e le suggestive statue dorate dei
tre martiri. Il Santuario è legato al culto dei tre martiri da
cui prende il nome.
La Chiesa Madre: tra i monumenti più importanti troviamo la
Chiesa Madre, dedicata a San Nicola di Bari. É la più antica
chiesa tra quelle dei paesi etnei. Risale al XV secolo e nel
1743 divenne collegiata. La sua struttura tipicamente
basilicale, a tre navate con absidi (una centrale e due
laterali), decorate con stucchi settecenteschi e un affresco di
P.P.Vasta.
Altri monumenti: la Chiesa della Madonna dell'Aiuto, la Chiesa
dei Bianchi, il Convento dei frati Francescani, la Chiesa di
Santa Caterina, la Chiesa di Sant'Antonio da Padova.
LE RICORRENZE
9-10 maggio: festeggiamenti in onore dei Santi Alfio, Delfio e
Cirino, protettori di Trecastagni
Agosto: mostra internazionale di pittura
TAORMINA
Su di una breve terrazza, formata da un caratteristico complesso
di rocce calcaree che si affacciano al tratto meridionale dei
Peloritani, nel sito dell'antica "Tauromenion", sorge la moderna
Taormina, a metà strada tra Messina e Catania, in una zona
paesaggistica che è tra le più belle ed incantevoli del mondo.
La città fondata da Andromaco nel 358 a. C. al tempo della
distruzione della calcidica Naxos ad opera di Dionigi, tiranno
di Siracusa, ebbe alterna fortuna attraverso i tempi della sua
millenaria storia. Ebbe un periodo di grande splendore sotto i
greci ed i romani e fu sede preferita dei bizantini e
successivamente anche loro capitale. Nel 902 venne distrutta
dagli arabi. Ricostruita dai Valdemoni con il nome di "Taormina
la nuova" venne nuovamente distrutta dagli arabi nel 962.
Conquistata dai Normanni nel 1079 Taormina risorse. Nel 1410 fu
scelta come sede di parlamento quando bisognava proclamare un
nuovo re per la Sicilia dopo la morte di Martino II e nel secolo
XVII chiese a Filippo V il privilegio di non essere più tolta al
demanio. Per il clima mite, le bellezze del paesaggio, il
patrimonio artistico e culturale Taormina, dotata di ottime
attrezzature ricettive, è una stazione di soggiorno di fama
mondiale e rappresenta una delle principali mete turistiche
italiane. Oltre l'industria alberghiera notevoli fonti di
reddito sono rappresentate da una fiorente agricoltura
(ortofrutticoli ed agrumi) e da un artigianato specializzato
nella produzione di souvenirs, nel ricamo e nella lavorazione
artistica del legno e dei metalli.
I MUSEI DI
TAORMINA
Il Museo Archeologico è stato a lungo desiderato, a lungo
negato, malgrado Taormina rappresentasse la culla
dell’archeologia siciliana, e non soltanto siciliana. Finalmente
si apre sotto l’egida del Comune e in stretta collaborazione con
la Soprintendenza di Messina. Nelle sale del bel palazzo
trecentesco della Badia Vecchia, esempio tra i più interessanti
del gotico siciliano, sono esposti i materiali dagli scavi più
recenti (1984-1998). Il filo che li congiunge è quello della
topografia antica della città, come ricostruibile dai grandi
monumenti ancora in luce e dai risultati della ricerca degli
ultimi decenni. Ma la ricerca archeologica inizia precocemente a
Taormina e coincide quasi con la nascita stessa
dell’Archeologia. I primi scavi nel teatro risalgono al ‘700 e
furono condotti dal principe de Spuches. Per illustrare questa
prima fase della ricerca, che continua ininterrotta nel ’800,
accanto ai reperti dagli scavi recenti sono in esposizione molti
di quelli appartenenti alla storica raccolta conservata nell’Antiquarium
del Teatro e principalmente formata da sculture. Con l’intento,
infine, di unificare, anche se solo per poco, nel loro luogo di
rinvenimento, sono confluite nell’esposizione anche reperti di
notevole interesse, scoperti a Taormina ed ora conservati in
Musei siciliani. Per le sue qualità artistiche, per il valore
documentario e per le stesse circostanze di rinvenimento, la
statua della sacerdotessa di Iside, senza dubbio, occupa un
posto di primissimo piano. Esempio raffinatissimo oltre ché raro
della scultura dell’avanzato II secolo d.C., la statua
rappresenta una delle testimonianze più efficaci e dirette del
culto di Iside e Osiride a Taormina. E’ scoperta nel 1861 da
Saverio Cavallari nel corso delle esplorazioni condotte
nell’area antistante la Chiesa di S. Pancrazio, costruita su di
un tempietto di tarda età ellenistica. Si tratta di un
importante ritrovamento, che, insieme a due iscrizioni, permette
di attribuire con certezza al culto delle Divinità Egizie il più
antico edificio: la statua è subito trasferita a Palermo, dove
entra a far parte delle collezioni del Museo Archeologico. In
esposizione sono anche taluni esemplari di oreficerie
ellenistiche e bizantine, acquistati da P. Orsi presso antiquari
taorminesi agli inizi del ‘900. Sono la testimonianza
dell’interesse dello studioso per Taormina e per il suo allora
fiorente mercato antiquario; interesse, che travalica
l’archeologia, come illustrano i vasi del sei, settecento in
maiolica, già della collezione Cacciola ed ora al Museo Bellomo
di Siracusa.
MUSEO
ETNOANTROPOLOGICO PALAZZO CORVAJA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
Il Palazzo Corvaja fu realizzato durante la dominazione araba
che a Taormina si protrasse dall’anno 902 all’anno 1079. Ha come
base una torre a forma di cubo che ricorda agli arabi la sacra
"Al Ka ‘bah", cioè il dado che, secondo Maometto, era il primo
tempio innalzato a Dio da Abramo alla Mecca. La torre fu
ampliata alla fine del tredicesimo secolo con l’aggiunta di
alcuni corpi di fabbrica. L’ala destra del Palazzo, in
particolare, fu realizzata agli inizi del 1400 per permettere le
riunioni del Parlamento siciliano del 1411 ed al quale partecipò
la regina Bianca di Navarra, reggente in Sicilia. E’ per questo
motivo che il palazzo è anche chiamato Palazzo del Parlamento.
Attualmente il Palazzo Corvaja è sede del Museo
Etnoantropologico nel quale sono esposti oggetti dell’arte e
della tradizione popolare del periodo compreso tra il XVI ed il
XIX secolo.
CLICK QUI PER VISITARE IL SITO
PALAZZO DUCHI
DI SANTO STEFANO
Il Palazzo
Duchi di Santo Stefano, che è uno dei monumenti più belli di
Taormina e dell’architettura medioevale siciliana, ospita la
"Fondazione Mazzullo" e le opere dell’artista siciliano.
L’intera struttura è stata acquisita dal Comune di Taormina nel
1963. Dopo il restauro è stata destinata ad ospitare le opere
dello scultore Giuseppe Mazzullo, nato a Graniti -piccolo centro
della valle dell’Alcantara a pochi chilometri da Taormina- nel
1913 e morto a Taormina nel 1988. Quasi tutte le sculture del
maestro siciliano sono state realizzate in pietra lavica.
Mazzullo è stato, senz’altro, uno degli artisti più
significativi dell’Italia del Novecento. Di lui e delle sue
opere hanno scritto alcuni dei maggiori critici, da Palma
Bucarelli a Marcello Venturioli, da Fortunato Bellonzi a
Ferruccio Ulivi, Nello Ponente, Marco Valsecchi, Mario De
Micheli. Ne hanno, inoltre, illustrato l’attività intellettuali
ed artisti come Cesare Zavattini e Renato Guttuso che
frequentavano lo studio dell’artista di via Sabazio a Roma
(1946-1970). Negli anni ’70 il maestro Mazzullo si trasferì a
Taormina e nel 1980, dopo una lunga trattativa, l’artista decise
di donare alla città che lo ospitava una trentina delle sue
opere, tra sculture e disegni, che furono collocate, in
esposizione permanente, nel Palazzo Duchi di Santo Stefano. Nel
1981 l’amministrazione comunale d’accordo con la famiglia dello
scultore, decise di costituire la "Fondazione Mazzullo" con sede
proprio nel Palazzo che si trova nei pressi di porta Catania, a
sud della città. L’attività della Fondazione è tesa alla
promozione d’incontri culturali ed artistici.
GIUSEPPE
MAZZULLO
Tra realismo ed espressionismo, l’arte di Mazzullo punta alla
ricerca dell’originario in natura, della "forma che è dentro".
Ecco il perché delle pietre che sembrano appena abbozzate, sulla
scia del "non finito" michelangiolesco. Negli ultimi anni della
sua vita, Mazzullo si impegnò, con maggiore attenzione, nella
ricerca dell’originario, del primitivo sino a giungere ad
un’espressività arcaica, ieratica, accentuata dalla suggestiva e
dura pietra lavica che richiama la scultura assiro-babilonese o
egizia. Il felice incontro delle suggestive statue di Mazzullo
con il Palazzo Duchi di Santo Stefano ed il suo bel giardino
ricco di piante mediterranee, ha reso la Fondazione Mazzullo uno
degli angoli più suggestivi e visitati di Taormina.
Chiese di
Taormina
Basilica Cattedrale - chiesa di S. Nicolò di Bari
piazza Duomo - tel. 0942 23123
Parroco: Sac. Cesare Cafeo D'Angiò
S. Maria Goretti
Taormina - Mazzeo tel. 0942 36595
Parroco: Sac. Giuseppe Di Bella
Sacro Cuore di Gesù
Taormina - Trappitello tel. 0942 50210
Parroco: Sac. Salvatore Arcidiacono
Chiesa Anglicana S. Giorgio
Via Pirandello, 10 tel. 0942 23859
DELL'ARCIPRETURA PARROCCHIALE SAN NICOLO'
DI BARI TAORMINA
CASTELMOLA
Castelmola è un comune che ha origine antichissime. Secondo il
Prof. Casagrandi ebbe la denominazione "Mylai" dai primi
navigatori ellenici che la scorsero in lontananza e che le
diedero questo nome per la sua caratteristica conformazione di
gran sasso rotondo, raffigurante o un enorme mola o una grande
macina da mulino sovrapposta ad una altura che funge da base. La
sua storia è legata strettamente a quella di "Tauromenion"
l'odierna Taormina tanto che le loro vicende sono spesso così
fortemente intrecciate da non poter distinguere quelle di una da
quelle dell'altra. Distrutta da Dionigi, di Siracusa, nel 392
a.C.,fu ricostruita nel 350 a.C. costituendo l'acropoli più alta
della Tauromenion Greco-Sicula. Sotto il periodo romano ebbe un
certo splendore, servì da rifugio per gli schiavi ribelli
durante le guerre civili (135-132a.C.). Successivamente subiva
l'invasione Musulmana. Risorgeva successivamente sotto il
periodo dei Normanni, pur rimanendo sempre nei modesti limiti di
borgo. Importantissimi sono i resti di una necropoli Sicula (X-VII
sec a.C.) in località "Cocolonazzo di Mola", il cui materiale
viene conservato nel museo archeologico di Siracusa. Per quanto
riguarda le attività economiche, c'è da rilevare che Castelmola
vive principalmente di attività terziarie connesse al turismo.
Nel settore dell'artigianato, invece, c'è da segnalare: la
produzione dei suddetti "scanni", antichi sgabelli costruiti in
legno di Ferla; il ricamo a mano di tessuti e i lavori in ferro
battuto.
SIRACUSA
http://www.apt-siracusa.it/
Città di mare, che nel mare si allunga con l'isola di Ortigia,
Siracusa è adagiata lungo una baia armoniosa. Il nome evoca
subito il passato greco, i tiranni e la rivalità con Atene e con Cartagine, passato di cui la città conserva numerose
testimonianze, questo si affianca un periodo forse meno
conosciuto, ma non meno suggestivo, che si rivive percorrendo le
stradine dell'isola, dove il tempo sembra essersi fermato in
bilico tra Medioevo e Barocco. Subito alle spalle di Ortigia si
estende l'Acradina, come veniva chiamata nell'antichità la zona
pianeggiante contigua ad Ortigia. E poi la Neaú polis, area
"nuova" dove si trova il teatro, l'Orecchio di Dionisio e la
latomia del Paradiso, una delle più belle, e, ad oriente, il
quartiere di Tyche che ricorda la presenza di un tempio dedicato
alla dea Fortuna (dal greco Tyche, il caso). Domina tutta l'Epipoli,
custodita e difesa dal castello Eurialo, in posizione elevata e
strategica.
ORTIGIA
Giace de la Sicania al golfo avanti
un'isoletta che a Plemirio ondoso
è posta incontro, e dagli antichi
è detta per nome Ortigia...
Virgilio, Eneide, Canto III.
Data la ricchezza di palazzi e di scorci interessanti, diviene
impossibile segnalare un percorso lineare che comprenda tutto
ciò che merita di essere visto. Qui di seguito si nominano
quindi solo le vie di maggior interesse lasciando alla fantasia
ed alla voglia di chi si addentra in questi angoli di storia,
l'emozione della scoperta dei particolari. Un consiglio:
viaggiate con il naso all'insù, per non perdere i segreti che
queste stradine, con i loro palazzi, racchiudono.
Uno sguardo alla costa...
L'isola, l'insediamento più antico della città, è legata alla
terraferma dal Ponte Nuovo, prolungamento di c.so Umberto I, una
delle principali arterie di Siracusa. Qui la sensazione del mare
si fa più forte fin dalla darsena che si stende sia a destra che
a sinistra del ponte ed è animata da barche colorate. Lasciando
vagare lo sguardo lungo la banchina si nota a destra, proprio
sull'angolo, un bel palazzo in stile neogotico: l'intonaco rosso
e le bifore della dimora del poeta e scrittore Antonio Cardile
(ME 1883-SR 1951) invitano il visitatore a proseguire il peniplo
dell'isola. L'atmosfera che si respira è più calma e pacata ed i
rumori sembrano giungere attutiti. Sulla destra il mare, sulla
sinistra le antiche mura spagnole che testimoniano come un tempo
(fino al 1800) tutta la città vecchia fosse fortificata. La
Porta Marina, la cui lineanità è spezzata da una bella edicola
in stile catalano, immette nel passeggio Adorno, creato sopra le
mura nel XIX sec. Oltre, lo sguardo abbraccia l'immensa distesa
del Porto Grande, in passato teatro di imponenti battaglie.
Fonte Arethusa - Sorgente di acqua dolce, ebbe nell'antichità un
ruolo determinante per l'insediamento del primo nucleo di
abitanti. L'esistenza della fonte è legata ad una leggenda.
Arethusa, ninfa di Diana perseguitata dall'amore del cacciatore
Alfeo, chiede aiuto alla dea che la fa fuggire lungo una via
sotterranea. Raggiunta così l'isola di Ortigia, la ninfa si
trasforma in fonte. Alfeo però non si perde d'animo e,
trasformatosi in fiume sotterraneo, passa lo Ionio fino a
raggiungere Ortigia dove mescola le sue acque con quelle di
Arethusa.
Oggi nella fonte, tra papiri e palme, nuotano anatre e papere.
Il fronte delle case, dai colori pastello, rende l'armoniosa
continuità che pervade anche le vie interne. Appare sulla punta
estrema dell'isola la mole del Castello Maniace (non
visitabile). Fortezza in pietra arenaria costruita da Federico
II di Svevia nella prima metà del XIII sec. lI nome è quello del
generale bizantino Giorgio Maniace che nel 1038 cerca di
sottrarre Ortigia agli Arabi, fortificando l'isola ed in
particolare il luogo dove poi Federico II riedificherà il
castello. La struttura squadrata e massiccia è tipica della
tipologia costruttiva sveva. Alcuni elementi architettonici
testimoniano come il castello probabilmente avesse funzione
difensiva, ma anche di rappresentanza. Proseguendo si raggiunge
la riviera di Levante da cui si gode di una bella vista del
Castello (la migliore resta quella che si gode dal mare). Si
supera la Chiesa dello Spirito Santo, dalla bella e bianca
facciata a tre ordini raccordati da volute e scandita da lesene,
e si raggiunge, lasciato alle spalle anche il Forte Vigliena, il
Belvedere S. Giacomo, un tempo baluardo difensivo, da dove si
gode di una bella vista su Siracusa.
...ed una passeggiata nell'interno
Piazza Duomo - Dalla forma irregolare e leggermente tondeggiante
lungo il lato che fronteggia la cattedrale, quest'incantevole
piazza si permea di un'atmosfera particolarmente suggestiva al
tramonto ed al calare della notte, quando viene illuminata. E'
delimitata da bei palazzi barocchi tra i quali spiccano la
notevole facciata di Palazzo Beneventano del Bosco, dalla bella
corte interna, con di fronte il Palazzo del Senato (nel cui
cortile è custodita una Carrozza del Senato del XVIII sec.) e la
Chiesa di S. Lucia a chiudere il lato corto.
Duomo - Il sito ove sorge il Duomo viene destinato fin
dall'antichità ad ospitare un luogo di culto. Ad un tempio
eretto nel VI sec. a.C. si sostituì il Tempio di Atena,
innalzato in onore della dea con i proventi della fatidica e
schiacciante vittoria ad Himera (480 a.C.) contro i Cartaginesi.
Il tempio viene inglobato, nel VII sec., in un edificio
cristiano: vengono innalzati muri a chiudere lo spazio tra le
colonne del penistilio e vengono aperte otto arcate nella cella
centrale per permettere il passaggio alle due navate laterali
così ottenute. Le imponenti colonne doniche sono ancora oggi
visibili sul lato sinistro, sia all'esterno che all'interno
dell'edificio. Forse trasformata in moschea durante la
dominazione araba, la chiesa viene rimaneggiata in epoca
normanna. Il terremoto del 1693 causò il crollo della facciata
che viene rifatta in forme barocche (XVIII sec.) dal palermitano
Andrea Palma che utilizzò come modulo compositivo basilare la
colonna. L'ingresso è preceduto da un atrio con un bel portale
fiancheggiato da due colonne a torciglioni lungo le cui spire si
avvolgono rami d'uva.
All'interno, il lato destro della navata laterale è delimitato
dalle colonne del tempio, che oggi danno accesso alle cappelle.
Nella 1° cappella di destra è conservato un bel fonte
battesimale formato da un cratere greco in marmo sostenuto da
sette leoncini in ferro battuto del XIII sec.
La cappella di S. Lucia presenta un bel paliotto argenteo del
'700. Nella nicchia è conservata la statua argentea della santa,
opera di Pietro Rizzo (1599). La cattedrale raccoglie molte
statue dei Gagini tra cui quella della Vergine (di Domenico) e
di S. Lucia (di Antonello) lungo la navata laterale sinistra e
la Madonna della Neve (di Antonello) nell'abside sinistra.
A nord della piazza, in via Landauna, si trova la Chiesa dei
Gesuiti, dall'imponente facciata.
Galleria Civica d'Arte Contemporanea - Ospitata nell'ex-convento
e chiesa di Montevergini (ingresso da via delle Vergini), la
collezione raccoglie opere principalmente pittoriche di artisti
contemporanei sia italiani che stranieri (Sergio Fermaniello,
Marco Cingolani, Aldo Damioli, Enrico De Paris).
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo - Palazzo Bellomo, sorto
in periodo svevo (XIII sec.), viene ampliato e sopraelevato nel
corso del XV sec. Si delineano così i due stili differenti: al
piano inferiore portale ad arco ogivale e feritoie che lo
rendono simile ad una fortezza: trifore sorrette da esili
colonnine a quello superiore. Dapprima palazzo privato, passò
nel '700 alle monache dell'attiguo monastero di S. Benedetto
oggi totalmente inglobato nella struttura museale. Contigua al
palazzo è ancora visibile la Chiesa di S. Benedetto dal bel
soffitto a cassettoni. L'interno del palazzo presenta al centro
un bel cortile porticato su cui si affaccia la scala che conduce
al piano superiore. Il parapetto è ornato nella fascia alta da
trafori a rosa e trilobati. Alla fine della prima rampa si trova
una bella edicola in stile flamboyant.
Il museo - E' dedicato in massima parte all'arte siciliana.
Chiaro lo stile bizantino di una bella serie di dipinti
cretesi-veneziani (sala IV) raffiguranti la creazione del mondo
(sei tavole), il peccato originale e la cacciata dal paradiso
terrestre. Il piano superiore è prevalentemente dedicato alla
pittura. Il pezzo più interessante è certamente la bella, ma
rovinata Annunciazione di Antonello da Messina. Come in molti
altri dipinti di questo artista si denota il gusto fiammingo per
i particolari (il manto del santo, il paesaggio popolato di
personaggi oltre la finestra) a cui si unisce il rigore formale,
compositivo e prospettico italiani. Il seppellimento di S.
Lucia, di Caravaggio, è forse ambientato nel sepolcro della
santa all'interno delle omonime catacombe. Lo stile drammatico e
provocatorio che caratterizza l'opera di questo artista si
delinea nella stessa scelta compositiva: la folla di persone che
si accalca alle spalle del corpo della santa, per terra, è
dominata dalle figure dei becchini, delle quali una, imponente
ed in primo piano, è di spalle. E la luce proietta ombre
inquietanti.
Il museo presenta inoltre una serie di oggetti artistici tra cui
arredi e paramenti sacri, presepi, mobili e ceramiche.
Poco lontano, in via S. Martino, l'omonima chiesa, il cui
impianto originario risale al VI sec., conserva un portale in
stile gotico-catalano.
Palazzo Mergulese-Montalto - E' un bellissimo palazzo, purtroppo
non in ottime condizioni, la cui costruzione risale al XIV sec.
La facciata si scandisce in due ordini divisi da un marcapiano
dentellato. La parte superiore è ornata da superbe finestre
elaborate, racchiuse da archi dal ricco intaglio e suddivise da
esili colonnine tortili. Al piano inferiore si apre il portale
ad arco acuto sormontato da una bella edicola. Dal palazzo si
può raggiungere la vicina piazza Archimede, di formazione più
recente. Animata al centro dall'ottocentesca fontana di Artemide,
è delimitata da bei palazzi.
Dalla piazza nasce via della Maestranza.
Via della Maestranza - E' una delle vie principali e più antiche
di Ortigia ed è fiancheggiata da abitazioni nobili di aspetto
barocco di cui, qui di seguito, segnaliamo le più significative.
Al n° 10 il Palazzo Interlandi Pizzuti e, poco più avanti,
Palazzo Impellizzeri (n° 17), che presenta una facciata ritmata
da finestre e balconi dalle linee sinuose. Poco oltre, Palazzo
Bonanno (n° 33), sede dell'Azienda Autonoma di Turismo, è una
severa costruzione medievale dalla bella corte con una loggia al
primo piano. Al n° 72 si eleva l'imponente Palazzo Romeo
Bufardeci, dall'esuberante facciata con balconi rococò. La via
si apre poi in una piazzetta coronata dalla Chiesa di S.
Francesco all'Immacolata cui si appoggia la torre campanaria
risalente all'800. La facciata chiara, convessa, è lineare e
scandita da colonne e lesene. La chiesa ospitava, nella notte
tra 28 ed il 29 di novembre, un rito di origine antica, la
Svelata, durante il quale veniva svelata l'immagine della
Madonna. Questo avveniva nelle prime ore dell'alba (per
permettere alla gente di recarsi al lavoro che un tempo iniziava
prestissimo). Durante la notte una banda musicale annunciava ai
fedeli l'inizio della celebrazione. Verso la fine della via si
delinea la facciata ricurva di Palazzo Rizza (n° 110). Palazzo
Impellizzeri (n° 99) domina la via dall'alto della sua sontuosa
ed originale cornice di volti umani e grotteschi sormontata da
motivi floreali.
Alle spalle dell'ultimo tratto si stende il Quartiere della
Giudecca dalla planimetria antica, con vie serrate e
perpendicolari tra loro. Venne abitato dalla comunità ebraica
durante il XVI sec., fino alla loro espulsione.
Mastrarua - Oggi via Vittorio Veneto, era un tempo l'arteria
principale di Ortigia. Era lungo questa via che il re entrava in
città ed era qui che si svolgevano processioni, parate ufficiali
e reali. E quindi logico che vi si affacciassero bei palazzi.
Alcuni tra i più significativi sono Palazzo Bianco (n° 41).
riconoscibile dalla statua di S. Antonio in un'edicola sulla
facciata e dal bel cortile interno con scalea, Casa Mezia (n°
47) il cui portale è sormontato da una mensola a forma di
grifone, e la Chiesa di S. Filippo Neri seguita dalla lineare
facciata di Palazzo Interlandi e da Palazzo Monforte, purtroppo
molto rovinato. Quest'ultimo fa angolo con via Mirabella lungo
la quale si allineano begli edifici. In particolare, proprio di
fronte a palazzo Monforte, si può ammirare l'elegante Palazzo
Bongiovanni. Il portone è sovrastato da una maschera sopra la
quale, ad aggetto, si trova la figura di un leone che regge un
cartiglio recante la data 1772, e che funge da sostegno centrale
di un balcone sagomato. La finestra centrale è segnata da
volute. Proseguire lungo via Mirabella. Una piccola deviazione a
destra permette di ammirare Palazzo Gargallo (oggi sede
dell'Archivio Distrettuale Notarile), in stile neogotico. In
corrispondenza di piazzetta del Carmine, si incontra anche
l'altro Palazzo Gargallo (n° 34), sempre nello stesso stile. Via
Mirabella segna anche l'inizio del quartiere arabo,
caratterizzato da vicoli, o ronchi, particolarmente stretti. In
uno di questi si trova anche la basilica paleocristiana di S.
Pietro, oggi auditorium, di cui si può ammirare il bel portale.
Sempre in via Mirabella, poco oltre, si incontra la chiesa di S.
Tommaso, di origini normanne (XII sec.). Riprendendo la
Mastrarua, al n° 111 si incontra un bel portale con esseri
mostruosi. Al n° 136,. invece, si trova la Casa Natale di Elio
Vittorini (nato il 23 luglio 1908).
Tempio di Apollo - L'edificio, costruito nel VI sec. a. C., è il
più antico tempio dorico periptero (racchiuso da colonne) della
Sicilia. Secondo un'iscrizione dedicato ad Apollo, secondo
Cicerone ad Artemide, è stato trasformato in chiesa bizantina,
poi in moschea e di nuovo chiesa sotto i Normanni. Si possono
ancora vedere resti di colonne del peristilio e una parte del
muro del recinto sacro.
Dalla piazza si diparte Corso Matteotti, passeggio di Ortigia,
fiancheggiato da eleganti negozi.
PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS
Vi sono due differenti ingressi: uno situato in via Rizzo e
l'altro in via Paradiso. Il percorso qui descritto prevede
l'entrata da via Rizzo.
Teatro Greco - E' uno dei più imponenti dell'antichità. La cavea
è stata completamente scavata nella pietra sfruttando la
naturale pendenza del colle Temenite. La data di costruzione è
stata stabilita intorno al V sec. a.C. in base alla notizia
della rappresentazione della prima dei Persiani di Eschilo. Ci è
giunto anche il nome del probabile costruttore: Damocopo, detto
Myrilla per aver utilizzato unguenti (miroi) all'inaugurazione
del teatro.
Il teatro viene modificato da Ierone II nel III sec. a.C.:
divisa in nove cunei, la cavea è percorsa, a metà circa, da un
corridoio. Lungo la parete, in corrispondenza di ogni settore,
viene inciso il nome di una personalità o di una divinità.
Ancora oggi è possibile distinguere le lettere che formano il
nome di Giove Olimpio (DIOS OLYMPIOS ) nel cuneo centrale e,
proseguendo a destra, fronte alla scena, quelli dello stesso
Ierone II (BASILEOS IERONOS), della moglie Filistide (BASILISSAS
FILISTIDOS), e della nuora Nereide (BASILISSAS NEREIDOS).
Adattato in epoca romana per giochi d'acqua (si suppone) e
combattimenti fra gladiatori prima della costruzione
dell'anfiteatro, lo spazio viene utilizzato anche in epoche
successive in modo improprio. Gli spagnoli infatti vi impiantano
dei mulini ad acqua.
Nel settore centrale della cavea sono ancora visibili i solchi
lasciati da due macine ed il canale di scolo dell'acqua. Alle
spalle della cavea si trova un grande spiazzo su cui si apre, al
centro, la cosiddetta Grotta del Ninfeo con vasca rettangolare
ravvivata dalle acque di un acquedotto greco che corre per circa
35 km e nasce dal Rio Bottiglieria, affluente del fiume Anapo,
nella zona di Pantalica. In disuso durante il Medioevo, nel XVI
sec, l'acquedotto viene riattivato dal marchese di Sortino per
alimentare i mulini impiantati nel teatro. Sulla sinistra si
apre la Via dei Sepolcri. Nelle pareti che la fiancheggiano sono
scavati ipogei di epoca bizantina e nicchie votive che
servivano, appunto, per depositare offerte.
Ancora oggi al teatro vengono messi in scena spettacoli classici
greci e latini che si svolgono durante l'estate (in giugno,
tutti gli anni pari).
Orecchio di Dionisio - Questa suggestiva grotta si trova in una
delle più belle latomie di Siracusa, la Latomia del Paradiso,
oggi un delizioso giardino ricco di aranci, palme, magnolie.
Come evoca il nome, l'aspetto della grotta richiama un
padiglione auricolare, sia nella sagoma dell'entrata che nel
disegno serpeggiante dell'interno. Fu Caravaggio, durante un suo
viaggio in Sicilia agli inizi del '600, ad assegnarle questo
nome, affascinato anche dalla leggenda secondo la quale Dionisio
il Vecchio, grazie all'eco eccezionale, avrebbe potuto
ascoltare, non visto, i suoi nemici.
La levigatezza delle pareti, così alte e regolari, e lo sviluppo
interno, quasi labirintico e sempre immerso nella penombra,
rendono difficile credere che si tratti di una cava. In realtà,
questa particolare conformazione è dovuta alla tecnica di scavo
utilizzata: una piccola fenditura nella parte più alta, poi
allargata verso il basso (forse seguendo il tracciato di un
acquedotto) man mano che si scoprivano strati di ottima pietra.
La grotta ha anche un'eccezionale acustica e non è raro
imbattersi in una guida, turista o curioso che si cimenta nel
canto dando bella prova di sè.
Molte le storie che circolano sulla grotta e sul suo utilizzo
una volta terminata: accanto all'ipotesi più veritiera che la
vuole adibita a prigione (come tutte le altre latomie) e a
quella più fantasiosa di "cornetto acustico" di Dionisio, c'è
anche chi sostiene che venisse utilizzata dal coro per gli
spettacoli al vicino teatro. Accanto si trova la Grotta dei
Cordari, così chiamata perchè utilizzata, fino a poco tempo fa,
da questi artigiani per intrecciare la corda in un ambiente
piacevolmente fresco. Visibile purtroppo solo dall'esterno (per
motivi di sicurezza) fornisce un ottimo esempio delle tecniche
di scavo.
Ara di Ierone II - E' un immenso altare, lungo circa 200 m ed in
parte ricavato nella roccia, eretto nel III sec. a.C, dal
tiranno per i sacrifici pubblici. Di fronte si apriva una grande
piazza rettangolare, probabilmente porticata, con al centro una
piscina.
Anfiteatro Romano - E' stato costruito in epoca imperiale
sfruttando la conformazione del terreno che ha permesso di
ricavare, direttamente nella roccia, metà della cavea. E' la
parte meglio conservata. L'altro emiciclo invece era formato da
grossi conci di pietra riutilizzati nelle epoche successive. Si
possono ancora distinguere i due ingressi, uno a sud ed uno a
nord. Al centro dell'arena si apre un vano rettangolare
collegato all'entrata sud tramite un fossato. Era uno spazio
"tecnico" destinato ai macchinari scenici per la realizzazione
di effetti speciali durante gli spettacoli.
Di fronte all'ingresso all'anfiteatro si trova la chiesetta
preromanica di S. Nicolò dei Cordari (XI sec.) sul cui lato
destro è visibile la piscina romana utilizzata per allagare
l'anfiteatro in occasione delle naumachie e per pulire l'arena
al termine dei combattimenti tra gladiatori e belve feroci.
Tomba di Archimede - Visibile solo dall'esterno da via
Romagnoli, angolo via Teracati. All'estremità orientale della
Latomia Intagliatella si estende la Necropoli Grotticelli. Tra
le cavità ricavate nella roccia, se ne evidenzia una
particolare, dall'entrata abbellita da colonne doriche (molto
rovinate) e da un frontone a timpano. E' la cosiddetta Tomba di,
Archimede, in effetti un colombario (ambiente con nicchie
destinate ad accogliere urne funerarie) di epoca romana.
Le Latomie
Le latomie, dal greco litos: pietra e temnos: taglio, sono le
antiche cave da cui venivano ricavati i blocchi di pietra
calcarea utilizzati per la costruzione di edifici pubblici e
grandi dimore. Dopo aver scelto la zona che offriva la
possibilità di estrarre conci regolari e di buona qualità, si
dava inizio allo scavo. Per estrarre la pietra si ricavavano
delle fenditure nelle quali venivano inseriti cunei di legno. Si
provvedeva poi a bagnare il legno che aumentava così di volume
spaccando la pietra.
Per trovare strati di pietra più compatta, lo scavo veniva
condotto in profondità, mediante l'apertura di grotte sempre più
imponenti. Per sostenere la volta di copertura di queste cavità,
venivano lasciati pilastri ricavati dalla roccia stessa. Si
calcola che in questo modo fosse possibile ottenere quantità
impressionanti di materiale. Una volta terminato lo scavo questi
ambienti venivano utilizzati come prigioni, come riferisce anche
Cicerone nelle Verrine. E' molto probabile che il luogo in cui
vennero segregati i 7000 Ateniesi fatti prigionieri nel 413 a.C.
fossero proprio le latomie. Rinchiusi per otto mesi, perirono
tutti, tranne alcuni che ebbero la fortuna di essere venduti
come schiavi e pochi altri che, narra la leggenda, seppero
citare i versi di Euripide a memoria. Si deve inoltre pensare
che a quei tempi l'aspetto delle grotte era sicuramente diverso:
esse erano più ampie, più tetre e più adatte allo scopo, mentre
quello che vediamo oggi è il risultato di crolli dovuti
soprattutto a scosse telluriche. Nelle epoche successive questi
spazi vennero invece utilizzati per cerimonie funerarie, come
rifugio e poi come aree coltivabili e solo ultimamente si è
pensato di rivalutarne l'importanza storica e recuperarle.
Tracciando una mappa di tutte le latomie (ne sono state
individuate 12, ma alcune sono state " seppellite" dalle
costruzioni), si nota che esse si dispongono lungo una sorta di
arco che corrisponde al profilo della terrazza calcarea che si
eleva approssimativamente al confine dei due antichi quartieri
di Neapolis e Tyche.
La più suggestiva è la Latomia del Paradiso che si trova nel
Parco Archeologico. Si tratta in effetti di un insieme di cave
attorno alle quali è sorto un delizioso giardino. Dall'alto (di
fianco al teatro greco) si riesce ad avere una visuale
complessiva ed a distinguere alcuni dei pilastri che
sorreggevano la volta di copertura delle grotte, crollata in
seguito a movimenti tellurici.
Procedendo lungo la linea, verso est, si incontrano la Latomia
Intagliatella, la Latomia di S. Venera, la Latomia del Casale e
la Latomia dei Cappuccini, forse la più grandiosa e spettacolare
grazie alle alte pareti scoscese.
MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE PAOLO ORSI
Situato, quasi nascosto alla vista, nel parco di Villa Landolina,
il museo rappresenta uno dei punti di riferimento fondamentali
per la conoscenza del periodo preistorico della Sicilia fino ai
tempi delle colonie di Siracusa.
La visita si articola lungo un percorso che segue la nascita e
lo sviluppo delle varie fasi in ordine cronologico. Le tre
sezioni principali, ben strutturate, sono correlate da una zona
introduttiva centrale, sotto la quale, nell'interrato, si trova
un auditorium nel quale vengono proiettati audiovisivi
(programmazione all'entrata).
Settore A: preistoria e protostoria - Aprono la visita le
raccolte di materiale fossile e di minerali, scheletri e resti
di animali preistorici corredati di ampie schede informative
sulla fauna insulare. Si passa quindi alle testimonianze umane
nel paleolitico e neolitico e alle varie culture susseguitesi.
Si tratta soprattutto di manufatti in ceramica tra i quali
emerge un grande vaso su un piede molto alto della cultura di
Pantalica: in ceramica monocroma rossa e lucida ha una linea
molto semplice ed elegante. Chiudono questa prima parte i
"ripostigli", insieme di oggetti di bronzo (punte di lance,
cinturoni, fibbie) racchiusi in un contenitore e nascosti alla
vista (sottoterra o in un anfratto).
Settore B: la colonizzazione greca - Vengono presentati reperti
che testimoniano la nascita e lo sviluppo delle colonie greche
nella Sicilia orientale. Tre sono le colonie ioniche: Naxos,
Katane e Leontinoi. Da quest'ultima proviene il bel Kouros
acefalo in marmo. Due invece le colonie doriche: Megara Hyblaea
e Siracusa, particolarmente rappresentate. La singolare statua
della Dea Madre che allatta due gemelli (VI sec. a.C.), in
calcare, proviene dalla necropoli di Megara Hyblaea. Acefala,
seduta, ha un corpo imponente e materno che si allarga ad
accogliere e contenere i due neonati che sembrano quasi divenire
un tutt'uno con lei. La collezione dedicata a Siracusa è molto
ricca e comprende due dei reperti più spesso riprodotti: la
lastra fittile a bassorilievo policromo di una gorgone,
proveniente dal Temenos deIl'Athenaion, ed il cavallino in
bronzo, simbolo del museo, ritrovato nella necropoli del Fusco.
Prima della sezione dedicata alla colonia di Siracusa è esposta
(provvisoriamente) la Venere Anadiomede, detta Venere Landolina
dal nome dello scopritore. Copia romana di un originale di
Prassitele largamente utilizzato come modello nell'antichità
(Venere Medici, Venere Capitolina), ha linee sinuose e gentili.
La grazia del gesto con cui sorregge il drappo è sottolineata
dal delicato panneggio plissettato che sembra suggerire, nella
forma, una conchiglia.
Settore C: subcolonie e centri ellenizzati - La prima parte,
dedicata alle subcolonie di Siracusa, presenta belle figure
antropomorfe tra cui quella di un cavaliere a cavallo. La
seconda invece illustra la storia dei centri minori. Spicca la
grande figura fittile di Demetra o Kore assisa in trono, opera
della seconda metà del VI sec. a.C. L'ultima parte è dedicata ad
Agrigento e Gela. Da quest'ultima provengono l'imponente
maschera di Gorgone dipinta, elemento del fregio decorativo di
un tempio ed una bella pelike attica a figure rosse, opera di
Polignoto.
Tre statuette arcaiche in legno provenienti da Palma di
Montechiaro costituiscono un raro esempio di arte votiva
probabilmente diffusa, ma poco testimoniata a causa della
deperibilità del materiale con cui veniva creata.
A PASSEGGIO PER "TYCHE" E "ACRADINA"
Museo del Papiro - La riscoperta del papiro a Siracusa è da
attribuirsi a Saverio Landolina che, nel XVIII sec., rivaluta la
presenza della pianta, utilizzata fino a quel momento a scopo
decorativo dalla popolazione locale, e riesce a riprodurre il
processo di fabbricazione della carta (nel museo ve ne sono
parecchi esempi).
Il materiale esposto nel museo copre tutti gli ambiti di
utilizzo del papiro, dagli scritti di epoca faraonica (tra cui
alcuni frammenti del Libro dei Morti), ai manufatti in corda, ai
ventagli, alle stesse varietà della pianta, alle imbarcazioni
leggere, adatte soprattutto alle zone paludose, con estremità
leggermente rialzate ed ancora utilizzate per caccia e pesca da
alcune popolazioni africane. L'ultima parte è dedicata alla
carta: dalla sua fabbricazione (ricostruzione di un tavolo da
lavoro) ai pigmenti e strumenti utilizzati dallo scriba.
Catacombe di S. Giovanni - Sorgono nella zona di Acradina, che
fin dal periodo romano è stato luogo deputato al culto dei
morti. Al contrario delle catacombe romane, scavate in fragile
tufo e quindi forzatamente anguste (per scongiurare il pericolo
di crolli), quelle siracusane sono state scavate in uno strato
di solida roccia calcarea che permise il crearsi di ampi spazi.
Le Catacombe di S. Giovanni, sorte intorno alla tomba di
S.Marciano, uno dei primi martiri, hanno una struttura complessa
e risalgono al IV-V sec. Si costituiscono intorno ad un
rettilineo principale ricavato seguendo il tracciato di un
acquedotto greco probabilmente in disuso. Da esso si staccano,
ad angolo retto, i cardini minori. I sepolcri si trovano lungo
le pareti e sono ad arcosolio e polisomi, cioè a più "posti",
fino ad un numero massimo di venti. Tra l'uno e l'altro si
trovano loculi più piccoli e meno profondi destinati ai bambini.
Ad intervalli si aprono aree circolari o quadrate, utilizzate
dai cristiani come camere sepolcrali di martiri e santi. Tra
queste la più nota è la Rotonda di Adelfia, ove è stato
ritrovato un bellissimo sarcofago scolpito con scene bibliche
(in attesa di collocazione probabilmente al 2° piano del Museo
Archeologico). Lungo il tracciato si incontrano inoltre cisterne
coniche di epoca greco-romana trasformate poi in cubicoli.
Cripta di S. Marciano - Si trova vicino alla necropoli, ove si
suppone sia stato ucciso il martire. A croce greca è circa 5 m
sotto il livello del terreno. La parete di fondo si apre in tre
piccole absidi semicircolari. In quella di destra si trova
l'altare dove si dice abbia predicato l'apostolo Paolo al suo
ritorno da Malta, nel 60 d.C (Atti degli Apostoli, cap. 28, 12).
Di fianco, sul lato destro si trova un sepolcro in muratura che
la tradizione identifica come quello del martire. Si tramanda
che la finestrella sul lato permettesse ai fedeli di vedere e
passare un panno sul corpo del santo per poi conservarlo come
reliquia. Ai quattro angoli della volta centrale si elevano
pilastri sormontati da capitelli bizantini con la raffigurazione
dei quattro evangelisti.
Basilica di S. Giovanni Evangelista - Sorge sopra la cripta.
Diroccata e scoperchiata, è uno dei luoghi più affascinanti di
Siracusa e la suggestione si fa più intensa al tramonto
soprattutto dei giorni festivi, al momento delle celebrazioni
religiose. Le origini della basilica sono legate alla cripta del
martire, sopra la cui sepoltura si era soliti edificare un luogo
di culto. Distrutta dagli Arabi, la basilica è stata
ripristinata dai Normanni. La facciata della chiesa normanna,
ornata di un bel rosone, è ancora visibile lungo il lato
sinistro. Il terremoto ha distrutto gran parte della chiesa e ha
fatto crollare il tetto, non più ricostruito. Il portico che
precede la facciata è una ricostruzione fatta utilizzando
materiale deI '400.
All'interno l'altare principale, fiancheggiato da un'euforbia a
candelabro, è bizantino.
Basilica di S. Lucia extra Moenia - Si affaccia sull'omonima
piazza, grande spazio rettangolare pervaso di tranquillità. La
tradizione vuole la sua edificazione nello stesso luogo del
martirio della santa awenuto nel 303 e testimoniato dalla tela
di Caravaggio (oggi a palazzo Bellomo). Bizantina, è stata
rimaneggiata in seguito, fino alla sua forma attuale, che risale
al XV-XVI sec. Le parti più antiche ancora esistenti sono il
portale della facciata, le tre absidi semicircolari e i primi
due ordini del campanile (XII sec.). Il soffitto ligneo a
capriate con decorazioni dipinte risale al XVII. Sotto la chiesa
sussistono le Catacombe di S. Lucia (non visitabili), presenza
che avvalorerebbe la tesi del martirio in questi luoghi.
Sulla stessa piazza, un piccolo edificio ottagonale, opera di
Vermexio, è il sepolcro destinato alla Santa, i cui resti,
portati a Costantinopoli nell'XI secolo dal generale bizantino
Maniace, poi a Venezia in seguito alla presa della città durante
la quarta crociata, sono oggi conservati nel Duomo.
Santuario della Madonna delle Lacrime - Visibile fin da lontano
per la sua struttura conica in cemento armato, imponente (80 m
di diametro alla base per 74 di altezza) e singolare, il
santuario è nato in seguito ad un evento prodigioso awenuto nel
1953 (la lacrimazione di un quadro della Madonna) ed è meta oggi
di numerosi fedeli. E opera degli architetti francesi M.
Andrault e P. Parat e dell'italiano R. Morandi che si è occupato
della parte strutturale. All'interno la vertiginosa sensazione
di altezza viene sottolineata e valorizzata dalle linee
verticali e dalle strette finestre che corrono verso l'apice.
Ginnasio Romano - Si trova lungo via Elorina, poco oltre il Foro
Siracusano, e, come quest'ultimo. faceva parte dell'antica agorà
di Acradina. La denominazione è errata. Si tratta in realtà di
un edificio complesso formato da un quadriportico, un piccolo
teatro di cui sono ancora visibili i gradini della cavea ed un
tempietto marmoreo che costituiva la scena.
"EPIPOLI"
Castello di Eurialo - Lungo via Epipoli, in località Belvedere,
a 9 km ca a nord-ovest. La strada che raggiunge la fortezza,
permette di rendersi conto dell'imponente aspetto difensivo che
la città assume sotto Dionisio il Vecchio. L'abile stratega,
oltre a fortificare Ortigia. decide di cingere la città di mura
inglobando anche i due quartieri di Tyche e Neapolis, fino a
quel momento extra-moenia. e quindi facili prede di attacchi. In
quest'ottica dà inizio alla costruzione delle imponenti mura
dionigiane (27 km) lungo l'altopiano dell'Epipoli, che racchiude
a nord la città. La cinta era costituita da due pareti parallele
di blocchi squadrati di pietra calcarea il cui interstizio era
riempito di pietrame. Alta 10 m e larga circa 3 m. era provvista
di postierle che assicuravano il passaggio senza offrire al
possibile nemico un facile punto di attacco, come invece
potevano essere le porte (proprio per questo erano affiancate da
torri difensive). Un tratto delle mura è visibile lungo la
strada che conduce a Belvedere (sulla sinistra).
Sulla sommità dell'altipiano viene edificato il castello,
chiamato Eurialo dal nome del promontorio su cui sorge, a forma
di testa di chiodo (gr. Euryelos). La fortezza è una delle più
imponenti dell'antichità. Tre erano i fossati da superare prima
di giungere al mastio, cuore della fortezza, e percorsi da
gallerie sotterranee che rendevano impossibile controllare il
passaggio delle guarnigioni e dei rifornimenti e facilitavano lo
sgombero dei materiali che i nemici gettavano nei fossati, Il
nemico, se mai fosse riuscito ad entrare, sarebbe rimasto
disorientato. L'ingresso della zona archeologica coincide con il
primo di quei fossati. Poco più avanti si delinea il secondo,
profondo, dalle pareti verticali ed infine il terzo, vera e
propria opera strategica. Quest'ultimo presenta tre piloni alti
e ben squadrati che testimoniano l'esistenza di un ponte
Ievatoio comunicante con l'area del mastio. Il lato orientale è
percorso da una serie di gallerie comunicanti una delle quali,
lunga addirittura 200 m, giungeva fino alla porta a tenaglia (Tripylon),
una delle uscite della fortezza. Lungo il lato occidentale del
fossato si aprivano invece dei vani adibiti a deposito per le
vettovaglie.
Alle spalle si erge il mastio quadrato, preceduto da un
imponente schieramento di cinque torri difensive. Oltre il
mastio si penetra in un recinto con ancora visibili, sulla
destra, tre cisterne quadrate. Sulla punta estrema, si gode di
un bel panorama su Siracusa (di fronte) e, a sinistra, sulla
piana.
FUORI CITTA'
Tempio di Giove Olimpico - Lungo via Elorina, a circa 3 km dalla
città, alla fine di una stradina che si diparte sulla destra
(indicazione).
In posizione panoramica, leggermente sopraelevato, il tempio è
stato costruito intorno al VI sec. a.C. L'aspetto, grandioso,
doveva essere pari all'importanza che l'edificio rivestiva.
Fonte Ciane - 8 km a sud-est. La foce del Ciane, che quasi si
unisce al vicino fiume Anapo, principale collegamento con la
zona interna di Pantalica è il punto di partenza per
l'escursione in barca che permette di risalire un tratto del
corso d'acqua. Appena partiti si giunge in vista del porto
grande di Siracusa (bel panorama) per poi proseguire lungo un
tratto ove la vegetazione è ricca di canne, frassini secolari ed
eucaliptus. Poi, oltre una chiusa, ci si immerge in una
rigogliosissima "folla" di papiri che si china sull'acqua. E'
qui che secondo il mito la ninfa Ciane, legata ad Anapo, si
oppone al rapimento di Persefone da parte di Ade e viene per
questo tramutata in sorgente.
STORIA
Colonizzata intorno all'VIII sec. a.C. dai Greci di Corinto che
si stanziano sull'isola di Ortigia. Siracusa cade ben presto in
mano a tiranni. Al momento del suo massimo splendore (V-IV sec.
a.C.) la città conta circa 300.000 abitanti e domina la Sicilia.
Tra il 416 ed il 413 si scatena un furioso conflitto tra
Siracusa ed Atene, i cui guerreri sono capeggiati da Alcibiade.
E' uno degli episodi più famosi e cruenti della storia antica.
Passata ai Romani, viene poi occupata dai barbari, dai
Bizantini, dagli Arabi e dai Normanni.
I tiranni di Siracusa - Il tiranno, figura antica che
corrisponde all'odierno dittatore, è uno dei personaggi che
spesso si incontra ripercorrendo la storia della Sicilia in
periodo ellenistico ed in particolare di Siracusa. Gelone, già
tiranno di Gela, nel 485 a.C. estende il suo dominio su
Siracusa. Le sue mire espansionistiche causano l'ostilità dei
Cartaginesi che si trasforma ben presto in aperto scontro.
Gelone, alleatosi con Terone, tiranno di Agrigento, riesce a
sconfiggerli nella celebre battaglia di Himera (485 a.C.). Gli
succede il fratello Ierone che durante il suo governo aiuta Cuma
a sbarazzarsi della minaccia etrusca (474 a.C.).
Dopo un breve periodo di democrazia caratterizzato da scontri
con Atene, sale al trono il famoso Dionisio il Vecchio
(405-367). Stratega accorto, basa il suo governo sul consenso
popolare, ottenuto attraverso regalie e favori, e sulla sua
figura di difensore contro il pericolo punico, che però non
riesce a sgominare. Sotto di lui Siracusa diviene una vera e
propria potenza. Da un punto di vista personale, invece, appare
come una figura sospettosa, timorosa di complotti contro di lui.
Le paure divengono vere e proprie manie di persecuzione e
sfociano nella sua volontaria reclusione nel castello di Ortigia,
da lui resa fortezza inespugnabile e dimora riservata alla
corte. La sua storia è costellata di stranezze che danno adito a
numerose dicerie, a metà tra la leggenda e la realtà. Narrano
quindi Valerio Massimo, Cicerone e Plutarco che, non fidandosi
dei barbieri, il tiranno affida alle figlie il compito di
raderlo, ma, intimorito che esse stesse possano ucciderlo, le
obbliga ad utilizzare gusci di noci arroventati al posto di
coltello e cesoie; fa scavare intorno al talamo nuziale un
piccolo fossato con un ponticello che toglie dopo essersi
coricato e, per dimostrare come la vita di un regnante sia densa
di pericoli, fa appendere sopra il capo di Damocle, cortigiano
invidioso, una spada affilata e sostenuta da un semplice crine
di cavallo (da qui la locuzione Spada di Damocle utilizzata per
esprimere l'incombere di una minaccia). La sua cupidigia lo
porta persino, si dice, ad appropriarsi del mantello aureo della
statua di Zeus e a farlo sostituire con uno di lana.
Alla sua morte sale il figlio, Dionisio il Giovane, non dotato
delle stesse capacità politiche del padre, seguito dal
sanguinario Agatocie, che per prendere il potere non esita a
massacrare gli aristocratici. Anche il suo tentativo di
scacciare i Cartaginesi dalla Sicilia si rivela vano (sconfitta
ad Imera nel 310 a.C.)
L'ultimo dei tiranni a governare Siracusa è Ierone II. Nel 212
la città passa nelle mani dei Romani sotto i quali diviene
capitale della provincia di Sicilia.
Le distrazioni di Archimede - Della vita di Archimede, celebre
matematico nato a Siracusa nel 287 a.C., non si hanno notizie
certe. Si narra che fosse così distratto ed assorto nei suoi
studi da dimenticare persino di bere e di mangiare. I suoi
servitori erano costretti a trascinarlo a forza ai bagni ed
anche là continuava a tracciare figure geometriche disegnando
nella cenere. E' nella sua vasca da bagno che scoprì il
principio che lo rese famoso: un corpo immerso in un liquido
riceve una spinta uguale e contraria al peso del volume di
liquido spostato. Raggiante si alzò di scatto e uscì di casa
correndo ed urlando "Eureka" (ho trovato!).
Si occupò di aritmetica, geometria, fisica, astronomia ed
ingegneria. Tra le sue invenzioni meccaniche vi sono la coclea
(o vite di Archimede), un cilindro contenente una superficie
elicoidale, la ruota dentata, le sfere celesti e gli specchi
ustori, un gioco di lenti e specchi con i quali riuscì ad
incendiare la flotta romana. Si narra inoltre che quando i
Romani riuscirono a penetrare nella città, Archimede, immerso
nei suoi calcoli, non se ne accorse e morì trafitto dalla spada
di un soldato.
Le muse di Siracusa - Durante il periodo antico la città svolge
un ruolo fondamentale per le arti. Molti dei regnanti infatti si
interessano anche dell'aspetto artistico ed accolgono poeti e
scrittori. C'è anche chi, come Dionisio il Vecchio, si cimenta
nello scrivere, pur senza grande successo. Il primo ad
interessarsi concretamente all'arte è Ierone I che si proclama
protettore dei poeti e riceve alla sua corte artisti del calibro
di Pindaro e Eschilo, padre della tragedia antica ed autore dei
Persiani (470 a.C ca) e delle Etnee, rappresentati nel teatro
greco che sorge nel quartiere di Neapolis. Platone ha con
Siracusa, ma soprattutto con i suoi regnanti, un rapporto
travagliato. Dionisio il Vecchio lo accoglie a malincuore, per
poi espellerlo poco dopo: alla sua morte il filosofo ritorna
(protetto dal reggente Dione), ma anche questa volta viene
espulso da Dionisio II e fallisce il suo progetto di creare uno
stato filosofico. Teocrito, iniziatore di quella poesia bucolica
in cui poi brillerà Virgilio, è probabilmente originario della
città. In tempi più recenti Siracusa dà i natali a Salvatore
Quasimodo (1901-1968), poeta pervaso del malessere di vivere che
esprime con versi sempre più ermetici e incisivi che gli
valgono, nel 1959, il Premio Nobel.
TURISMO
Siracusa dal mare - E' possibile compiere il giro del Porto
Grande e dell'Ortigia, affidandosi alla Motonave Selene che da
marzo a novembre (ed oltre, se il tempo ed il mare lo
permettono) naviga sottocosta offrendo una visuale ed una
prospettiva diversa della città. Il giro, della durata media di
35 min, può essere "allungato" a piacere ed includere, su
prenotazione, il pranzo o la cena. Particolarmente suggestivo il
percorso nelle ore del tramonto o di notte quando i singoli
punti di interesse vengono di volta in volta illuminati. E bene
sottolineare che questo è anche l'unico modo per avere piena
visione ravvicinata del Castello Maniace che, in quanto caserma
militare, non è visitabile nè visibile dalla terraferma (se non
dal lungomare di Levante).
Non solo alberghi - Il Domus Mariae è un piccolo ed elegante
albergo gestito da religiose, proprio nel cuore di Ortigia. La
zona di Siracusa e provincia offre una serie di alternative al
più tradizionale albergo, quali il campeggio ed i centri
agrituristici. Gli indirizzi e le caratteristiche sono
disponibili presso l'Azienda Provinciale per l'Incremento
Turistico di Siracusa. E per cenare si consiglia di restare in
Ortigia ove i vicoli nascondono ristoranti caratteristici
NOTO
In una regione in cui abbondano olivi e mandorli,
Noto è un
piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che domina la
valle dell'Asinaro, coperta di agrumi. La sua bellezza, così
armoniosa da sembrare una finzione, la scena di un teatro, nasce
da un fatto tragico: il terremoto del 1693, che in questa parte
di Sicilia portò distruzione morte, ma diede impulso alla
ricostruzione. Prima di allora la città sorgeva a 10 km di
distanza. Di origini assai antiche, Noto diede i natali a
Ducezio, che nel V sec. a.C. fece tremare i Greci per aver fatto
insorgere contro di loro i Siculi. Il terremoto del 1693
distrugge completamente la città. Per la ricostruzione viene
scelto un luogo meno impervio e più vasto, che permetta la
realizzazione di un impianto semplice, lineare, con intersezioni
ad angolo retto e strade parallele ed ampli come vuole il nuovo
gusto barocco. Tre le strade principali che corrono da est a
ovest perchè il sole le illumini sempre. Tre i ceti sociali che
vi si stabiliscono: la prima, Più alta, viene destinata alla
nobiltà, la centrale al clero (l'unica eccezione è il palazzo
secolare dei Landolina), l'ultima al popolo. I palazzi sono
maestosi, tutti costrui nella pietra calcarea locale, tenera e
compatta, dal candore che il tempo ha colorato creando quella
magnifica tinta dorata e rosata che la luce del tramonto
accentua, questa ricostruzione, condotta dal Duca di Camastra,
rappresentante a Noto del vicerè spagnolo, partecipano molti
artisti siciliani, tra i quali Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra e
Rosario Gagliardi, che, influenzato da Borromini, è forse uno
dei più inventivi. La cittàviene costruita come se fosse una
scenografia, studiando e truccando le prospettiva in modo
singolare, giocando con le linee e le curvature delle facciate,
con le decorazioni delle mensole, i riccioli e le volute, i
mascheroni, i putti, i balconi dai parapetti in ferro battuto
che si piega in forme aggraziate e panciute. Creazione originale
c maestri locali. Noto si inserisce comunque nel panorama che
dalle mani degli artisi italiani vede fiorire il sogno barocco
in tutta Europa e che dà vita alla nuova capitale russa, San
Pietroburgo.
IL CENTRO BAROCCO
L'asse principale è corso Vittorio Emanuele, scandito da tre
piazze. In ogni piazza una chiesa, il corso è annunciato dalla
Porta Reale, monumentale ingresso a forma di arco di trionfo,
eretto nel XIX sec. La porta è sormontata da un pellicano,
simbolo dell'abnegazione nei confronti di Re Ferdinando. Ai due
lati si trovano una torre, simbolo di fortezza ed un cirneco
(antica razza canina siciliana), sinbolo di fedeltà. Alle spalle
si stende un viale alberato fiancheggiato dal bel Giardino
Pubblico caratterizzato dalle macchie viola della bougainvillea
e dai ciuffi delle palme tra i quali emergono i busti marmorei
di famose personalità locali. E' uno dei luoghi di ritrovo degli
abitanti.
Piazza Immacolata - E' coronata dalla facciata barocca,
abbastanza semplice, di S. Francesco all'immacolata (opera di Sinatra) preceduta da un'imponente scalinata che in alto si apre
in una terrazza delimitata dall'omonimo convento e con al centro
la statua della Vergine. All'interno della chiesa, sono
custodite opere provenienti dalla chiesa francescana di Noto
antica, tra cui una Vergine col Bambino in legno dipinto
attribuita a Antonio Monachello (1564) (sull'altare) e, lungo a
navata, sulla destra, la lastra tombale di un padre francescano
(1575). A sinistra della chiesa, all'imbocco di via S. Francesco
d'Assisi, si eleva il bel Monastero dei SS. Salvatore con
l'elegante torre dalla facciata curvilinea, antico belvedere.
Deliziose le panciute grate in ferro battuto alle finestre che
caratterizzano anche il Convento di S. Chiara (sul lato opposto
del corso), opera del Gagliardi.
Piazza Municipio - E' la più maestosa e movimentata delle tre
piazze, delimitata a sinistra dalla facciata mossa di Palazzo Ducezio, a destra dalla sinuosa scalinata della Cattedrale cui
si affiancano due belle esedre.
Cattedrale - L'ampia facciata, scandita da due campanili che la
delimitano, lascia intravedere in secondo piano i resti della
cupola, purtroppo crollata, con gran parte della navata
centrale, nel 1996. L'edificio è preceduto da un'amplissima
scalinata digradante nella piazza e fiancheggiata da due esedre
alberate, ciascuna sovrastati da un percorso lastricato che ne
sottolinea l'andamento curvilineo. Ai lati della cattedrale,
allo stesso livello, il Palazzo Vescovile (XIX sec.) e Palazzo
Landolina di Sant'Alfano hanno linee più sobrie e sembrano
controbilanciare l'esuberanza degli altri edifici.
Il lato opposto della piazza è invece occupato dalle armoniose
linee curve di Palazzo Ducezio, cinto da un porticato
classicheggiante, opera di Sinatra. Fino agli anni '50 il piano
superiore non esisteva.
Il lato orientale della piazza è coronato dalla facciata della
Basilica del SS.Salvatore.
Via Nicolaci - Proseguendo lungo corso Vittorio Emanuele, sulla
destra. Lo sguardo si lascia condurre lungo questa via,
leggermente in salita, chiusa a monte dalla Chiesa di
Montevergini, dalla bella facciata concava inquadrata tra due
campanili, opera di Sinatra. I due lati della via sono
fiancheggiati da bei palazzi barocchi. Spicca, sulla sinistra,
Palazzo Nicolaci di Villadorata dai balconi esuberanti, con
mensole fantasiose a forma di putti, cavalli, sirene e leoni e
figure grottesche tra cui spicca, al centro, un personaggio
dalle fattezze tipicamente mediorientali (naso camuso e labbra
grosse). Terminati i lavori di restauro il palazzo riaprirà le
sue sale al pubblico.
Verso metà maggio, dietro i portoni dei palazzi, fa capolino la
gente del posto circondata da un tappeto coloratissimo: sono i
petali che serviranno a comporre l'infiorata. Il selciato della
via si trasforma in una lunga tela che gli artisti riempiono di
pennellate di petali variopinti, a formare quadri ogni anno
diversi.
Ritornando in corso Vittorio Emanuele si incontra poi, sulla
sinistra, l'imponente complesso della Chiesa e Collegio dei
Gesuiti attribuito a Gagliardi, il bel portale centrale è
racchiuso da quattro colonne sovrastate da mascheroni mostruosi.
Piazza XVI Maggio - E' dominata dall'elegante facciata convessa
della Chiesa di S.Domenico, opera di Gagliardi, definita da
linee vigorose, sottolineate dalle colonne sovrapposte che
scandiscono i due ordini divisi da un alto cornicione.
L'interno, bianco, coperto di stucchi, ha altari in marmo
policromo.
Davanti alla chiesa si trova la deliziosa Villetta d'Ercole con
al centro l'omonima fontana, settecentesca. Di fronte si staglia
l'ottocentesco Teatro Vittorio Emanuele III.
Via Ruggero VII, seconda traversa sulla sinistra di corso
Vittorio Emanuele, permette di raggiungere la Chiesa del
Carmine, caratterizzata da una bella facciata concava e da un
portale barocco. Ritornando in piazza XVI Maggio, salire lungo
via Bovio, fiancheggiata sulla destra dalla Casa dei Padri
Crociferi.
Via Cavour - E' la via sovrastante e parallela a corso Vittorio
Emanuele. Passaggio nobile, è fiancheggiata da edifici
interessanti tra cui Palazzo Astuto (n° 54) con bei balconi
dalle ringhiere bombate e Palazzo Trigona Cannicarao (n° 93).
Superato il palazzo voltare a sinistra in via Coffa e in fondo
ancora a sinistra. Costeggiato Palazzo Impellizzeri, in stile
tardo-barocco, voltare a destra in via Sallicano. In fondo
prospetta la Chiesa del SS. Crocefisso, progettata da Gagliardi.
All'interno è conservata la Madonna della Neve di Francesco
Laurana, dai tratti delicati.
Uno sguardo diverso
Andar per vicoli - Tutt'intorno all'impianto regolare
settecentesco del centro storico, sono "sorti" i quartieri
popolari (Agliastrello. Mannarazze, Macchina Ghiaccio, Carmine)
caratterizzati dagli stretti, tortuosi e spesso labirintici
vicoli che contraddistinguono i borghi medievali. L'associazione
Allakatalla, oltre ad offrire un servizio di visite guidate per
il centro storico, organizza percorsi alternativi in questi
quartieri e li arricchisce con racconti e leggende popolari. Un
vero e proprio tuffo nel passato, ancor più suggestivo se fatto
la sera, quando le luci soffuse creano un'atmosfera quasi
magica. Allakatalla, largo Porta Reale, 10/3 0931/ 8350050.
DINTORNI
Noto
Antica
- 9 km ca a nord-ovest. Lungo la strada che conduce
al luogo ove sorgeva la città vecchia, un'indicazione segnala
l'Eremo di S. Corrado fuori le Mura, immerso nel verde. Vicino
al santuario, settecentesco, si può visitare la grotta ove, nel
XIV sec. visse il santo. Riprendendo la strada si incontra poi
il Santuario di S. Maria della Scala. All'interno, alle spalle
del fonte battesimale, si trova un bell'arco in stile
arabo-normanno. Poco più avanti si giunge al sito ove sorgeva
Noto prima del terribile terremoto deI 1693. L'antica città si
sviluppava lungo il crinale dell'Alveria, chiusa tra due
profonde gole che rendevano il sito facilmente difendibile.
Attraverso la Porta Aurea ci si addentra fra le strade, un tempo
gremite di gente ed ora immerse nella vegetazione, in un
suggestivo percorso segnato da pochi ruderi che sbucano tra gli
arbusti.
Cava Grande (Laghetti di Avola) - 19 km ca a nord. La visita a
Cava Grande consente di scoprire i paesaggi nascosti degli lblei,
il massiccio carsico che occupa la porzione sud-orientale della
Sicilia, lungo un itinerario poco frequentato e di notevole
interesse naturalistico. Percorrendo la strada che collega
Palazzolo Acreide a Noto, seguire la deviazione per Avola e poi
la strada secondaria con indicazione turistica per Cava Grande.
Si giunge al Belvedere, abbandonare l'auto. Da qui si gode di
una bella vista sulla Gola di Cava Grande con le imponenti
pareti calcaree a picco sul fondovalle, occupato dal corso
d'acqua che si apre in suggestivi piccoli laghetti,
raggiungibili percorrendo il sentiero che scende nella gola.
Leggermente sulla sinistra, si intravede un'apertura scavata
nella roccia. E' la cosiddetta Grotta dei Briganti, solo una
piccola testimonianza di quegli insediamenti rupestri che
caratterizzano tutte le zone rocciose del sud-est della Sicilia.
Si pensa che questa in particolare fosse una conceria.
Discesa - In mezz'ora di cammino (ma il ritorno in salita
richiede un tempo almeno doppio), si raggiunge il fiume (la
"cava" secondo un toponimo locale). Per tracce talvolta poco
evidenti si costeggia il corso d'acqua, seguendo il verso della
corrente, immersi nella vegetazione rigogliosa. Dopo alcune
centinaia di metri si raggiunge una zona aperta dove il fiume
forma una successione di limpide piscine naturali scavate nella
roccia e contornate da massi appiattiti, ideali per una sosta al
sole. Nella stagione estiva le fresche acque invitano al bagno
in quest'ambiente che sembra estraneo al paesaggio tipico
siciliano e che costituisce un'alternativa insolita e
consigliabile.
ACI CASTELLO
Piccolo borgo marinaro sulla costa orientale della Sicilia, nel
tratto chiamato a ragion veduta Riviera del Limoni, è una delle
nove "sorelle" accomunate dal prefisso Aci. Questo tratto di
litorale, oltre ai numerosi limoni, è ricca di agavi e palme.
Il castello - In nera pietra lavica, questa fortezza normanna è
arroccata su uno sperone di roccia sul mare ed è visibile dalla
strada. Il luogo è fortificato fin dai tempi dei Romani quando
qui sorgeva la Rocca Saturnia. Più volte distrutta venne
riedificata da re Tancredi nel 1189. Sotto i Borbone (1787) il
castello venne adibito a prigione. Dalla cima si gode di una
bella vista sui Faraglioni dei Ciclopi e sull'Isola Lachea. Il
castello ospita un piccolo Museo Civico a sfondo didattico che
riunisce minerali e reperti archeologici.
STORIA
Aci e Galatea
Figlia di Nereo, ninfa marina, Galatea si innamora di Aci,
pastore figlio di Pan. Della fanciulla purtroppo si accorge
anche Polifemo, il terribile ciclope avversario di Ulisse. La
ninfa gli resiste e, sconvolto dalla gelosia e dall'odio, il
mostro dagli antri del Mongibello uccide il pastorello. Zeus,
colto da pietà per il dolore della nereide, tramuta allora
l'amante in fiume, (l'attuale Akis) che scorrendo verso il mare,
dimora di Galatea, permette il perpetuarsi degli incontri dei
due amanti.
Le nove Aci - Narra una leggenda popolare che il corpo del
pastorello ucciso da Polifemo si sia smembrato in nove parti
cadute dove poi sono state fondate Aci Bonaccorsi, Aci Castello,
Aci Catena, Aci Platani, Acireale, Aci S. Filippo, Aci S.
Antonio, Aci S. Lucia ed Aci Trezza. La costa viene anche
chiamata Riviera dei Ciclopi.
MASCALI
Mascali si sviluppa a 18 metri sul livello del mare, nella parte
piu' a valle del Parco dell'Etna, esattamente nella zona che
giunge al litorale ionico.
In epoca normanna - dal 1092 - il centro rientrava nel feudo
posto sotto la baronia comprendente anche le attuali Giarre,
Milo, Riposto, e S. Alfio affidata al Vescovo di Catania. Nel
XVI secolo la baronia fu trasformata in contea e tale rimase
fino al 1812.
Il centro attuale nasce dalla ricostruzione imposta
dall'eruzione dell'Etna avvenuta nel 1928.
Tra i principali monumenti della citta' occorre ricordare la
Chiesa Madre che si presenta con la sua struttura interna
comprendente tre navate dove si possono ammirare, tra l'altro,
una settecentesca statua in marmo rappresentante il patrono
cittadino, San Leonardo.
Nei dintorni cittadini ed esattamente alle pendici dell'Etna si
trova la frazione Nunziata dove si trova la Chiesa della
Nunziatella risalente al XII secolo che raccoglie degli
affreschi tra cui spicca quello raffigurante il Cristo
Pantocratore. Nelle vicinanze della Chiesa e' stata ritrovata
una necropoli risalente al VII secolo.
L'ETNA E IL SUO
VULCANO
Punto culminante della Sicilia, incappucciato dalla neve nel
periodo invernale, l'Etna, ancora attivo, è uno dei più famosi
vulcani d'Europa. La sua altezza, continuamente modificata dalle
eruzioni, è oggi circa 3350 m s.l.m. L'altro nome dell'Etna,
Mongibello, deriva da una errata interpretazione dell'arabo
Gebel, monte, cui è stato aggiunto una seconda volta
l'appellativo. Etna sarebbe così un suggestivo "due volte
monte".
IL VULCANO E LA SUA STORIA
L'Etna nasce da eruzioni sottomarine che, in epoca quaternaria
(circa 500.000 anni fa), formano anche la Piana di Catania,
prima occupata da un golfo. Le eruzioni dell'Etna nell'Antichità
sono assai numerose, almeno 135. Nel Medioevo il vulcano erutta
nel 1329 e nel 1381, seminando il terrore nella gente che vive
nella zona. Ma è nel 1669 che ha luogo il cataclisma più
terribile: il torrente di lava scende fino al mare devastando in
parte Catania al suo passaggio. In epoca più
recente le eruzioni più rilevanti sono quelle del 1910 con la
formazione di ventitrè
nuovi crateri, quella del 1917 quando una fontana di lava
zampilla fino ad 800 m al
di sopra della sua base, quella del 1923 dopo la quale la lava
eruttata resta calda per oltre diciotto mesi.
Le ultime esplosioni di "collera" del vulcano hanno luogo nel
1928 quando una colata, di lava distrugge Mascali, nel 1954,
1964, 1971, 1974, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, fino a quella
del 1991 che termina dopo ben tre anni.
L'Etna mantiene sempre il suo pennacchio di fumo e può in
qualsiasi momento entrare in attività.
Tutt'intorno ai crateri, le colate di lava nere se sono recenti,
grigie quando invece risalgono a tempi più lontani e cominciano
a ricoprirsi di licheni, testimoniano con la loro presenza e,
qua e là, con i loro funesti effetti (strade interrotte, edifici
distrutti) l'incessante attività del vulcano.
A quasi 3000 m di altitudine, sul versante del cratere centrale,
nella zona Torre del Filosofo il cui rifugio è stato distrutto
dalla lava nel 1971, appaiono quattro crateri: quello di
sud-est, nato nel 1978, l'immenso cratere centrale, quello di
nord-est, la cima più alta, la cui attività non si è più
manifestata dopo il 1971, e la Bocca Nuova, ultimamente la più
attiva.
Per informazioni dettagliate sull'attività dell'Etna consultare
il capitolo dedicato al Vulcanismo.
PARCO
Istituito nel 1987, il parco copre un'estensione di 59000 ha.
La montagna appare come un enorme cono nero, visibile in un
raggio di 250 km. Alla sua base, estremamente fertile,
prosperano numerose colture di aranci, mandarini, limoni, olivi,
agavi, fichi d'india, nonchè banani, eucalipti, palme, pini
marittimi e viti da cui si produce eccellente vino Etna. Tra la
vegetazione spontanea, invece, particolarmente presente è
l'euforbia arborea. Sopra i 500 m crescono noccioli, mandorli,
pistacchi, castagni che più in alto lasciano il posto alle
querce, ai faggi, alle betulle ed ai pini, soprattutto nella
zona di Linguaglossa (si veda oltre). Il paesaggio a queste
quote è inoltre caratterizzato dalla ginestra dell'Etna.
Superati i 2100 m di quota ha inizio la zona desertica dove si
trova lo spinosanto (Astragalus siculus), piccolo cespuglio
spinoso, a cui spesso si trovano associate variopinte varietà
endemiche di viole, seneci e altri fiori che popolano le pendici
dei crateri secondari. Verso le punte più elevate, la neve e la
lava calda per lungo tempo, impediscono la crescita di qualsiasi
tipo di vegetazione macroscopica. E' il
cosiddetto deserto vulcanico.
Il parco dell'Etna ospita anche una fauna variata di piccoli
mammiferi (istrici, volpi,
gatti selvatici, donnole, martore, ghiri), volatili (gheppi,
poiane, fringuelli, picchi,
upupe), alcuni rettili, tra cui la vipera, e moltissime farfalle
tra le quali spicca l'Aurora deIl'Etna (Anthocharis damone)
LE ESCURSIONI
Molti sono gli itinerari possibili all'interno del parco, sia
percorsi brevi che escursioni più lunghe, più complesse tra cui
La Grande Traversata Etnea -GTE- (5 giorni di trekking con tappe
dai 12 ai 15 km), sentieri natura e, per i più pigri, la
circumetnea sia in auto (si veda oltre) che in treno.
Quest'ultima utilizza il tratto ferroviario che
"circumnavigando" l'Etna, parte da Catania ed arriva a Riposto.
Da qui, per rientrare a Catania è possibile prendere un autobus.
Per informazioni, rivolgersi allla Ferrovia Circumetnea
095/541246.
Per informazioni dettagliate sui percorsi ci si può rivolgere
all'Azienda Provinciale
di Catania tel. 095/317722, all'Azienda di Soggiorno e Turismo
di Nicolosi
tel 095/911505 o alle Pro Loco dei comuni etnei tra cui
Linguaglossa (tel. 095/643094), Zafferana Etnea (tel. 095/70
82825) ed al Gruppo Guide Alpine Etna Sud a Nicolosi tel.
095/7914755).
Ascensione al vulcano - A causa delle eruzioni dell'Etna, le
attrezzature turistiche (strade, piste, funivie, rifugi) non
hanno carattere definitivo e possono
essere rimosse o soppresse a seconda della gravità dei danni
arrecati dall'eruzione più recente. Le escursioni sul vulcano
possono essere annullate in caso di maltempo (pioggia, nebbia).
E' utile tenere presente che, soprattutto per il versante
nord-est, il periodo in cui l'escursione è possibile varia ogni
anno a seconda delle nevicate. All'inizio della stagione
(normalmente a maggio) vengono effettuate gite più brevi che
raggiungono quote meno elevate, solo quando le strade sono state
liberate dalla neve e, nel tratto più alto, è passata la ruspa,
si raggiunge quota 3000. Il periodo migliore per effettuare
l'escursione quindi è
normalmente la piena estate. Il momento migliore sono le prime
ore del mattino.
Equipaggiamento - Sia per le escursioni a quota più bassa che
per quelle che
invece raggiungono le altitudini più elevate (si veda oltre) è
necessario tener presente che, sebbene ci si trovi in Sicilia,
qui la temperatura può raggiungere minime molto basse. E' quindi
consigliabile essere equipaggiati con un maglione ed una giacca
a vento e calzare scarpe adatte (meglio se scarponcini da
trekking, perchè spesso in alto si trova la neve). Chi dovesse
arrivare sprovvisto del giusto abbigliamento, può comunque
noleggiare giacche a vento e scarpe adatte. Inoltre, dato che il
riverbero del sole può essere molto intenso, è meglio essere
sempre provvisti di occhiali da sole.
LE VIE DELL'ETNA
L'ascesa al vulcano può essere effettuata sia dal versante nord
che dal versante
sud. I due percorsi offrono panorami e caratteristiche diverse.
Più brullo, nero e desertico il percorso che da Nicolosi porta
al Rifugio Sapienza, immerso nel verde il tratto che conduce a
Piano Provenzana.
Dalla costa al versante sud
Percorso di 45 km con partenza da Acireale - 1/2 giornata ca
Diversi sono gli approcci per raggiungere il versante sud del
vulcano, quello più
brullo, nero di lava frantumata a formare un paesaggio
dall'aspetto lunare. Molti
sono i paesini da cui si può passare per raggiungerlo e tutti
hanno in comune una caratteristica: la pietra lavica a
pavimentare le strade, ad ornare portali e finestre delle case,
a creare mascheroni resi più minacciosi dal colore scuro, a
sottolineare le linee delle chiese.
DINTORNI
Aci Sant'Antonio - La piazza Maggiore custodisce alcuni dei
principali monumenti
cittadini ed è dominata dall'imponente facciata del Duomo,
ricostruito dopo il
terribile terremoto del 1693. Di fronte si erge la
cinquecentesca chiesa di S. Michele Arcangelo. Dalla piazza si
snoda la centrale via Vittorio Emanuele chiusa, in fondo, da ciò
che resta del palazzo della famiglia Riggio.
Viagrande - Il centro del paese è pavimentato a grandi lastroni
di pietra lavica.
La settecentesca Chiesa Madre ha una facciata scandita dalla
stessa scura pietra
che sottolinea le linee verticali, i portali e le finestre che
li sovrastano.
Trecastagni - Contrariamente a quanto si possa pensare, il nome
si riferisce ai tre santi (tre casti agni, cioè agnelli) qui
venerati: Alfio, Filadelfio e Cirino. E' qui che ha luogo la
festa dei tre santi con la processione del ceri, alcuni
pesantissimi, che tra il 9 ed il 10 maggio vengono portati dagli
ignudi fino al Santuario di S. Alfio, all'inizio del paese. Via
Vittorio Emanuele, fiancheggiata da bei palazzi, permette di
giungere ai piedi della Chiesa Madre di S. Nicola,
caratterizzata da un campanile centrale. L'edificio è preceduto
da una ripida scalinata fiancheggiata, sulla destra, da
un'esedra che più in alto si scompone in un gioco di rampe
asimmetriche. In alto, una terrazza permette di godere di una
bella vista sulla piana sottostante.
Tra cucina e folclore - Il ristorante Villa Taverna, in corso
Colombo 42 a Trecastagni, offre una particolarissima
ambientazione e ripropone la ricostruzione di alcuni angoli del
centro storico catanese, quasi una scenografia completa di
oggetti che fanno rivivere un'epoca passata. La cucina propone
un menù tipico siciliano a prezzo fisso.
Pedara - Piazza Don Diego è dominata dal Duomo, che presenta una
singolare
cuspide maiolicata a vivi colori.
Nicolosi - E'considerata la porta dell'Etna. Qui hanno sede le
guide Alpine Etna
Sud (tel. 095/7914755) e da qui si snoda la bella strada che
conduce fino al Rifugio Sapienza, luogo di partenza per le
escursioni al cratere.
Verso la cima dell'Etna - Il percorso permette di scoprire un
volto inusuale e
proietta il visitatore in unta dimensione quasi fantastica, ove
le note dominanti sono il nero della lava e l'azzurro del cielo
con, qua e la, qualche spruzzo bianco di neve.
Prima di giungere al rifugio, un'indicazione segnala i Crateri
Silvestri, una brevissima passeggiata a quota 1886 m. ma che ci
catapulta sulla luna, con i suoi crateri.
Ascesa al versante sud - L'escursione si svolge parte in funivia
(dal Rifugio
Sapienza) fino a 1923 m, parte in fuoristrada (fino a 2608 m).
L'ultimo tratto a piedi. Per ragioni di sicurezza non è più
possibile avvicinarsi
alla bocca centrale. Si giunge però, dopo un breve cammino, ad
una zona "calda", in cui la terra fuma.
La gita prevede anche una sosta in fuoristrada nei pressi della
Valle del Bove, vasta zona depressa (da qui l'appellativo valle)
delineata da muraglie di lava alte fino a 1000 m in cui si
aprono crepacci e voragini. La zona è stata spesso teatro di
eruzioni di cui alcune particolarmente pericolose, in cui la
lava è riuscita a raggiungere i centri abitati (1852, 1950, 1979
e 1991).
Il versante nord-orientale
Percorso di 62 km con partenza da Linguaglossa - 1 giornata ca
Linguaglossa - Il paese, letteramente due volte lingua (Glossa
in greco) testimonia, nell'ipotesi più intrigante, la sua
posizione "calda" proprio sulle pendici
dell'Etna che spesso furono invase da sciare di lava
incandescente. La piazza centrale è caratterizzata dalla
presenza della Chiesa Madre, in pietra lavica e arenaria.
All'interno, si può ammirare un bel coro ligneo del 1728 con
scene della vita di Cristo.
La Pro Loco di Linguaglossa, lungo la via principale del paese,
funge da principale
punto di riferimento per le escursioni sull'Etna. Materiale e
pannelli esplicativi
all'interno della sede aiutano a conoscere il parco ed il
vulcano, a programmare
le gite.
Lungo la strada Mareneve, fiancheggiata da una bella pineta di
pini lanci, si giunge fino a Piano Provenzana dove si può
lasciare la vettura per effettuare l'escursione ai crateri
sommitali.
Ascesa al versante nord - In un bellissimo percorso, il pulmino
fuoristrada raggiunge i 3000 m ca di altitudine. Su questo
versante è stato installato il nuovo
osservatorio che ha sostituito quello distrutto dalla lava
durante l'eruzione del 1971 (durata 69 giorni) che ha
interessato sia il versante sud (ove oltre all'osservatorio
viene "cancellata" la vecchia funivia), che il versante
orientale ove la colata lavica arriva a minacciare alcuni centri
abitati (Fornazzo, Milo) per fermarsi a circa 7 km dal mare.
Dalle vicinanze dell'osservatorio, a 2750 m ca, si
gode di una magnifica vista. Si prosegue poi fino a quota 3000.
Qui si abbandona il fuoristrada per procedere a piedi e vedere
da vicino quelle terribili sbuffanti bocche che a seconda del
loro umore decidono di risparmiare le terre attorno o di mondane
di una sciara, o di fuoco vivo. Il percorso varia a seconda dei
capricci del vulcano. Lungo il ritorno, viene effettuata una
sosta a 2400 m d'altitudine, per vedere i crateri protagonisti
dell'eruzione del 1809.
La strada orientale - Una volta ritornati a Piano Provenzana si
può proseguire
lungo la strada panoramica Mareneve che costeggia la zona
sommitale dal lato est. Sulle basse pendici del versante
orientale dell'Etna, si trovano numerosi paesini agricoli che
sfruttano la fertilità del suolo vulcanico per coltivare vite ed
agrumi. In località Fornazzo, appena prima di immettersi sulla
strada che collega Linguaglossa con Zafferana Etnea, si giunge
fino all'incredibile colata lavica che, nel 1979, ha
"rispettato" la piccola Cappella del Sacro Cuore (sulla
sinistra) sebbene addossandosi ad uno dei muri e riuscendo a
penetrare un poco
all'interno: Oggi è meta dei numerosi fedeli che vedono in
questo un evento miracoloso e vi portano numerosi ex-voto. Da
Fornazzo una breve deviazione sulla sinistra permette di
raggiungere Sant'Alfio.
Sant'Alfio - Il paesino possiede una monumentale Chiesa Madre
secentesca ma rimaneggiata nel XIX sec., con una singolare
facciata a campanile in pietra lavica. Dalla terrazza antistante
la chiesa si gode di una splendida vista sulla costa ionica.
L'attrattiva principale di S. Alfio è però il castagno dei 100
cavalli (sulla provinciale per Linguaglossa), un maestoso
esemplare di più di duemila anni, il cui tronco, formato da tre
distinti polloni, ha una circonferenza di 60 m. Il nome gli
deriva da una leggenda, secondo la quale la regina Giovanna (non
si sa se Giovanna d'Aragona, regina di Castiglia o Giovanna d'Angiò
regina di
Napoli) vi trovò riparo in una notte di tempesta con il suo
seguito di 100 cavalieri.
Ritornare in direzione Fornazzo e proseguire a sinistra verso
Milo.
Milo - Piccolo borgo agricolo, Milo deve la sua sopravvivenza
nel corso del tempo
all'imprevedibile e cieco cammino della lava che lo ha sempre
risparmiato. Molte
volte infatti, la colata è giunta vicinissima (nel 1950, 1971 e
1979) ed alla fine ha
deviato il suo corso.
Proseguire in direzione di Zafferana Etnea e raggiungere
Trecastagni e poi Nicolosi per poi proseguire sul versante sud o
verso Catania.
LA CIRCUMETNEA
(INFORMAZIONI AGGIUNTIVE)
Circuito di 154 km ca - 1 giornata
La strada che corre tutt'intorno all'Etna, permettendo di
cogliere immagini sempre
diverse del vulcano, tocca alcuni interessanti paesini.
Catania.
Misterbianco - L'imponente chiesa settecentesca di S. Maria
delle Grazie eleva la sua bella facciata sopra le case del paese
ed è visibile fin da lontano. All'interno,
nell'abside di destra, è custodita una Madonna col Bambino
attribuita ad Antonello Gagini.
Paternò - Nel 1072, Ruggero II edifica sull'alto di una rupe un
castello dalle forme
squadrate, ma ingentilite, su uno dei lati, da una serie di
bifore: una linea di quattro più piccole coronate da una molto
più grande sopra. Il nero della lava contrasta con il candore
degli elementi architettonici che risultano così molto evidenti.
Intorno al castello sorgono anche i centri religiosi. Si
costruisce la chiesa madre (di origine normanna, ma rifatta nel
'300) e la Chiesa di S. Francesco. La
cittadina si sviluppa invece ai piedi della rupe ed ha un
assetto secentesco.
Santa Maria di Licodia - Il centro della cittadina è costituito
da piazza Umberto,
in posizione sopraelevata è delimitata dall'ex-monastero
benedettino (oggi Municipio) e dalla Chiesa del Crocifisso.
Defilata lungo il lato sinistro della chiesa si può ammirare una
bella torre campanarla (XlI-XIV sec.) con decorazione a fasce
bicrome.
Adrano - Una delle cittadine etnee più antiche (le prime tracce
risalgono all'epoca neolitica) Adranon sarebbe stata fondata dal
tiranno Dionisio I nel V sec. a.C. Si possono ancora vedere
resti delle mura ciclopiche a grossi blocchi squadrati in pietra
lavica (seguendo via Catania e poi una deviazione a destra con
segnaletica gialla). In periodo normanno viene costruito il
Castello che ancora oggi troneggia nella centrale piazza
Umberto. Squadrato, in pietra lavica, risale nella sua forma
attuale all'epoca sveva. Al suo interno sono ospitati tre musei.
Il Museo Etnoantropologico raccoglie oggetti di artigianato
locale. Il Museo Archeologico Regionale, dislocato su tre piani,
nipercorre attraverso i reperti la storia della zona (ma anche
di altre aree della Sicilia orientale) dal Neolitico all'età
bizantina.
Particolarmente degni di nota sono: (il banchettante, bronzetto
di officina samia
(seconda metà del VI sec. a.C.) che decorava probabilmente un
bacile in bronzo o una cesta, il busto in terracotta di una
divinità sicula femminile rinvenuto in contrada Primosole (V
sec. a.C.). un busto fittile femminile di tipo locrese (V
sec.a.C.).
un gruppo fittile raffigurante Eros e Psiche e uno splendido
cratere attico a colonnette (V sec.a.C.) (tutti i reperti citati
sono al 2° piano). All'ultimo piano si trova la Pinacoteca in
cui sono esposti dipinti su tela (tra cui opere dello Zoppo di
Gangi, di Filippo Paladino e Vito D'Anna), vetro e metallo,
sculture in legno, alabastro, bronzo databili dagli inizi del
XVII agli inizi del XX sec. e una serie di opere di pittura e
scultura contemporanee di artisti adraniti e non.
La piazza si allunga a est nel piacevole giardino della Villa
comunale, su cui si
affaccia l'imponente prospetto della Chiesa e Monastero di S.
Lucia. La facciata della chiesa, bicroma, è opera settecentesca
di Stefano Ittar.
Centrale Solare Eurelios - Si trova a pochi chilometri da Adrano
ed è stata realizzata nell'ambito di un progetto di ricerca
dell'allora CEE, grazie al contributo di un consorzio
italo-franco-tedesco. La centrale dopo una fase di
sperimentazione durata dal 1981 al 1987 non è più utilizzata
(poteva generare
una potenza di 1 MW): attualmente si sta invece sperimentando la
produzione di
energia elettrica a partire dall'energia solare tramite pannelli
fotovoltaici (costituiti da celle di silicio), nell'ambito del
progetto dell'Enel di fornitura di energia ai rifugi di montagna
o edifici isolati.
Ponte saraceno - Si trova fuori città, lungo il fiume Simeto.
Uscire da Adrano a sud e seguire le indicazioni per Bronte. Si
giunge ad un bivio ed un cartello segnaletico indica il ponte. A
sinistra ed a destra la strada è asfaltata; di fronte diparte
invece una strada sterrata. Imboccarla e seguire il tracciato
principale fino al fiume dove si trova il ponte. Di origine
romana, il ponte è stato ricostruito sotto Ruggero II e
rimaneggiato nelle epoche successive. Le arcate ogivali sono
sottolineate da una fascia bicroma. Un breve percorso sulla
sponda del fiume verso nord permette di scoprire le belle Gole
del Simeto, anch'esse formate, come le gole dell'Alcantara (si
veda alla voce) da una colata lavica (questa volta dell'Etna)
"ripulita" dall'acqua che ha levigato i grandi massi basaltici.
Bronte - In centro al paese sorge il Collegio Capizzi,
prestigiosa scuola settecentesca ospitata in un bel palazzo. A
qualche chilometro di distanza, nei pressi di Maniace, anche se
territorialmente sotto questo comune, si trova la bella Abbazia
benedettina di Maniace, poi trasformata nel "Castello di
Nelson".
Castello di Nelson
Da Bronte seguire le indicazioni. Si trova appena prima di
Maniace. L'abbazia benedettina fondata nel XII sec.: per volontà
della regina Margherita, moglie di Guglielmo il Malo, era
situata lungo un'importante via di comunicazione con
l'entroterra della Sicilia. La cappella annessa presenta un bel
portale con capitelli stonati. All'interno si trova un'icona
bizantina del XIII sec. ma popolarmente creduta l'originale
portata dal condottiero bizantino Giorgio Maniace che nel 1040
inflisse una dura sconfitta agli Arabi proprio in questi luoghi.
Il fiorente monastero subisce diverse modifiche, e viene alla
fine donato da Ferdinando III all'ammiraglio inglese Nelson neI
1799.
Randazzo.
Linguaglossa
Dirigersi verso la costa, imboccando la deviazione per Marina di
Cottone.
Riserva naturale del fiume Fiumefreddo - Il Fiumefreddo sgorga
dalle pendici
nord-orientali dell'Etna dove, per l'elevata permeabilità delle
rocce vulcaniche,
l'acqua si infiltra nel terreno e riaffiora poi in pianura,
grazie alla presenza di un
substrato argilloso impermeabile. L'alveo del fiume è alimentato
essenzialmente da
due risorgive, quella di Testa dell'Acqua e le Quadare (in
dialetto siciliano paiola),
profonde fino a 10-12 m. Per apprezzare la profondità e la
limpidezza delle acque
si consiglia di effettuare la visita nelle ore in cui il sole è
più alto. L'acqua del fiume, che non supera mai una temperatura
di 10-15°C anche in estate e ha la caratteristica di defluire
lentamente, favorisce la presenza di una particolarissima
vegetazione acquatica in cui a specie tipiche dell'Europa
centrale come il ranuncolo a pennello si associano specie
"africane" come il papiro. Altre specie vegetali presenti sono:
il salice bianco, il giaggiolo acquatico, il pioppo tremulo,
l'equiseto o erba cavallina. La presenza delle sorgive favorisce
inoltre la
sosta degli uccelli di passo: aironi, beccacce, ricocoli e molti
anatridi. Nella zona
limitrofa alla riserva si trova il settecentesco Castello degli
Schiavi (privato, non visitabile), opera degli architetti
Vaccarini e Ittar.
Giarre - La cittadina faceva parte della contea di Mascali,
concessa in feudo al
vescovo di Catania da Ruggero II nel 1124. Il toponimo deriva
infatti dalle giare in
cui venivano raccolte le decime dovute al vescovo su tutti i
prodotti della terra. Il
Duomo è un'imponente costruzione neoclassica, con due torri
campananie gemelle, di forma squadrata. L'arteria principale è
via Callipoli, fiancheggiata da bei negozi e da residenze
signorili, tra i quali è degno di nota il Palazzetto Bonaventura
(n° 170), in stile liberty. Al n° 154, Palazzo Quattrocchi è
caratterizzato da decorazioni in stile moresco.
Da Giarre dirigersi verso la costa in direzione di Riposto.
Riposto - Era qui che venivano "ripostate" le decime raccolte
nella contea di
Mascali, che dovevano essere trasportate via mare. Il borgo si
sviluppò infatti ad
opera di una colonia messinese (da cui il culto della Madonna
della Lettera) attorno ai magazzini e nel XIX sec. divenne un
importante centro commerciale per l'esportazione del vino. Vi
sono infatti numerosi resti di edifici industriali del secolo
passato. Il grazioso Santuario della Madonna della Lettera,
prospiciente il mare, fu
eretto nel 1710, anche se un edificio religioso esisteva
probabilmente già in epoca
normanna, come dimostrano gli scavi sotto il santuario che hanno
portato alla luce delle cripte con colatoi per cadaveri di epoca
paleocristiana, monete di epoca arabo-normanna e resti
architettonici del periodo aragonese. Il quadro della Madonna
col Bambino, di incerta datazione, è posto su un altare
settecentesco. Interessante il coro ligneo scolpito realizzato
alcuni anni fa e singolare il lampadario barocco con decorazioni
in madreperla, di probabile fattura locale.
|
|